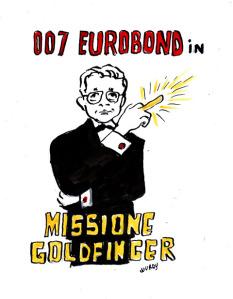PAYPAL: Clicca qui
STRIPE: Clicca qui
In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro conto
Titolare del conto: Come Don Chisciotte
IBAN: BE41 9674 3446 7410
BIC: TRWIBEB1XXX
Causale: Raccolta fondi
IN RISPOSTA A TREMONTI E AI VENDITORI DI FUMO
DI DANIEL GROS*
FONTE: Sollevazione
Consigliamo ai lettori di leggere quest’articolo,
senza farsi spaventare dai tecnicismi, inevitabili in questo genere
di trattazioni. Gros non è certo un “anticapitalista”,
anzi. Questa degli Eurobond, spacciati come ancora di salvezza dell’Unione
e dell’euro, spiega Gros, è una leggenda, anzi, fumo negli occhi. Segnaliamo
che tra i sostenitori di questa “panacea” non ci sono soltanto
i vampiri della finanza speculativa (uno su tutti: Warren Buffet), ma
praticamente tutta la corazzata di fede “europeista” della
sinistra ufficiale: Prodi ovviamente, il Pd, l’Idv, Sel, pezzi del Prc,
mentre la CGIL della cornuta e mazziata Camusso ha pensato bene di metterli
nella piattaforma per lo sciopero del 6 settembre.
Gli eurobond sono propagandati
come la panacea per risolvere la crisi dell’euro. Questo articolo sostiene
che la proposta degli eurobond non è valida per motivi giuridici,
politici ed economici. Si dice che, qualunque sia la variante, gli
eurobond hanno senso solo in un’unione politica e, in considerazione
delle grandi differenze nei sistemi politici nazionali e nella loro
qualità di governo, qualsiasi unione politica creata sulla carta nella
pratica non funzionerebbe.
Col termine “Eurobond”
di solito si intende un’obbligazione garantita “in solido”
da tutti gli stati membri della zona euro (vedi, ad esempio, Manasse
2010 e Suarez 2011). La garanzia “in solido” implica
che, se il paese emittente non può servire il proprio debito in “Eurobond”,
i creditori possono chiedere il pagamento a tutti gli altri paesi della
zona euro. Ciò implicherebbe che in extremis i creditori potrebbero pretendere che l’Estonia
o la Finlandia paghino per il debito accumulato, diciamo, dalla Grecia
o dall’Italia, se gli altri grandi dell’eurozona non vogliono o non
possono pagare.
Questo articolo si occupa solo dell’ipotesi
che gli Stati membri possano essere in grado di emettere Eurobond
per finanziare i loro deficit e convertire soltanto in parte
il loro debito.
Perché
gli investitori acquisterebbero gli Eurobond?
I fautori degli Eurobond affermano
che potrebbero essere venduti a un rendimento molto basso, vicino a
quello del benchmark tedesco “Bund”. L’idea è che,
poiché il debito complessivo e i livelli di disavanzo della zona euro
reggono bene il confronto con quelli degli Stati Uniti, gli investitori
presterebbero a tassi di interesse simili. Tale idea è, ovviamente,
completamente diversa da quella di un’istituzione comune che dovrebbe
essere in grado di finanziare compiti di interesse condiviso (vedi Gros e Micossi 2008).
Ma questa è una proposta che
non è stata (e purtroppo non può essere) testata e la conclusione
non è scontata, soprattutto se gli Eurobond dovessero coprire
gran parte del debito esistente:
numerosi provvedimenti per affrontare la crisi del debito dell’Eurozona
sono stati poi revocati dai politici e che quindi questi potrebbero
non avere piena fiducia nella garanzia “in solido”;
– gli investitori potrebbero anche avere una visione diversa dei rischi del debito sovrano nella zona euro e potrebbero non credere nelle garanzie date in solido;
– potrebbero anche avere un parere
diverso sugli effetti di incentivazione che deriverebbero dagli Eurobond.
– gli operatori di mercato potrebbero
aspettarsi che l’introduzione degli Eurobond porti a un aumento
più rapido del debito complessivo.
– gli investitori potrebbero anche
avere una visione diversa dei rischi di credito sovrano nella zona euro,
dato il più alto livello d’indebitamento bancario (2,5% del PIL
rispetto al “solo” 1,2% degli Stati Uniti).
È interessante notare che gli oppositori
degli Eurobond tendono a essere molto più pessimisti per quanto
riguarda il livello del tasso di interesse. Per esempio Ifo (2011), presuppone che il tasso di interesse sugli
Eurobond sarebbe uguale alla media (ponderata) dei rendimenti sul
debito pubblico in essere nella zona euro, che attualmente è di quasi
200 punti base più elevato del rendimento sul debito pubblico tedesco.
Un altro argomento verte sul grado di liquidità di tali obbligazioni.
Naturalmente, gli eurobond diventerebbero un asset ad
alta liquidità, con un volume di debito disponibile paragonabile ai
buoni del tesoro statunitensi. Tuttavia, i differenziali di rendimento
tra piccole e grandi emittenti con rating AAA all’interno della zona
euro (ad esempio la Germania contro l’Austria) sono nell’ordine di 30-50
punti base. Il miglioramento della liquidità, quindi, al massimo potrebbe
rappresentare un beneficio minore.
Qual
è il problema che gli Eurobond dovrebbero risolvere?
La proposta di introdurre gli Eurobond
in questo momento, ovviamente, non vuole risolvere i problemi di lungo
periodo, ma serve ad affrontare l’attuale crisi, dando l’accesso a un
finanziamento più conveniente ai governi dei paesi che attualmente
stanno pagando alti premi per il rischio.
le differenze dei premi di rischio sono giustificate dalle differenze
nella politica fiscale nazionale e costituiscono un utile segnale di
mercato che costringe i governi a regolarsi.
– Per i sostenitori degli Eurobond,
le differenze possono includere gli alti premi al rischio dovuti semplicemente
al panico.
Qualsiasi paese con un livello del
debito moderatamente elevato potrebbe essere portato all’insolvenza
– anche se questo debito fosse perfettamente sostenibile a bassi tassi
di interesse – perché quando i mercati svendono il debito del governo,
l’economia ristagnerà e l’onere del debito aumenterà.
Gli economisti li chiamano “equilibri
multipli”. Se gli investitori ritengono che l’Italia è fondamentalmente
solvente, acquisteranno titoli di Stato italiani a un tasso di interesse
inferiore, diciamo, al 5%. In questo caso il servizio del debito sarà
sostenibile e le banche italiane saranno in grado di rifinanziarsi senza
problemi sul mercato interbancario. Ma se molti investitori hanno dubbi
sulla solvibilità del paese, i tassi di interesse saranno spinti in
alto e le banche del paese saranno tagliate fuori dal mercato interbancario.
L’economia quindi andrà in riserva, riducendo le entrate pubbliche
proprio nel momento in cui il governo deve affrontare maggiori costi
del servizio del debito (vedi Gros
2011 sull’importanza della
connessione banche-debito sovrano).
Questi dubbi sulla solvibilità
di un paese possono chiaramente essere auto-avveranti e condurre a una
veloce spirale verso il basso dei mercati finanziari, come ha dimostrato
il panico di questa estate. Una serie di recenti contributi di VoxEU
ha affrontato questo temi, più di recente de Grauwe (2011). Vedi anche Kopf (2011).
Ma quanto
è importante questo fenomeno degli equilibri multipli?
Nei primi mesi del 2010, quando la
Grecia ha iniziato ad affrontare delle difficoltà per vendere i suoi
debiti sul mercato, molti hanno anche sostenuto che questo era solo
un caso di panico auto-avverante presente sul mercato. È risultato,
tuttavia, che gli scettici del 2010 avevano ragione sulla Grecia. Nonostante
una massiccia dose di aiuti finanziari il paese non è stato in grado
di riportare il suo bilancio sotto controllo. Non si dovrebbe quindi
saltare alla conclusione che tutti gli aumenti dei differenziali di
rischio costituiscano attacchi speculativi ingiustificati. Ma è difficile
sfuggire all’impressione che, in un dato momento, questo meccanismo
possa guidare i mercati.
I pericoli di introdurre l’unione
politica senza legittimità democratica
“Niente tasse senza rappresentanza”
è un principio fondamentale della democrazia, ma non è compatibile
con la responsabilità solidale sul debito di altri paesi della zona
euro, a meno che l’Europa (o meglio la zona euro) diventi un’unione
politica. Rendere i contribuenti dei paesi parsimoniosi pienamente e
incondizionatamente responsabili per le decisioni di spesa prese in
altri paesi si trasformerebbe molto probabilmente in una pillola di
veleno per l’UEM. La resistenza politica contro l’UEM aumenterebbe nei
paesi più forti e condurrebbe a una sua probabile rottura.
Inoltre, se l’emissione di Eurobond
fosse limitata a una parte del debito nazionale (ad esempio, solo il
40-60% del PIL, come proposto), i paesi fortemente indebitati sarebbero
immediatamente costretti a una ristrutturazione del debito in quanto
non potrebbero più trovare acquirenti per la parte garantita soltanto
a livello nazionale. Per questo motivo il sistema di obbligazioni blu/rosse
proposto da Delpla e Weizsäcker (2010) – The Blue Bond Proposal –
non può funzionare se i paesi interessati hanno un eccesso di debito.
Le obiezioni legali agli eurobond
sono ben note. Qualsiasi patto di responsabilità multipla solidale
è in contrasto con la clausola del no-bailout (non salvataggio)
del trattato di Lisbona (art. 125). Così, sarebbe necessaria una revisione
del trattato che richiede la ratifica da parte di tutti i 27 membri.
Il destino del Trattato di Lisbona, che è stata respinto quando sottoposto
a referendum in Francia e nei Paesi Bassi, dovrebbe funzionare da avvertimento.
Inoltre, la Corte Costituzionale Tedesca molto probabilmente potrebbe
considerare incostituzionali gli Eurobond senza un’unione politica
e potrebbe imporre al governo tedesco di lasciare la zona euro o ritirare
la sua garanzia incondizionata agli Eurobond.
Mettere il carro davanti ai buoi?
Creare un’unione politica per giustificare gli Eurobond?
I fautori degli Eurobond affermano
che gli elementi necessari a una “unione politica” potrebbero
essere creati, se necessario, modificando i Trattati dell’UE. È chiaro
che la sorveglianza sovranazionale da parte della Commissione, del Consiglio
(zona euro) e del Parlamento dovrebbe essere rafforzata al punto che
quasi certamente interferirebbe con i principi costituzionali di ogni
Stato membro per quanto riguarda l’autonomia di bilancio dei Parlamenti
nazionali. Un maggiore coinvolgimento del Parlamento Europeo non sarebbe
utile allo scopo, dato il “deficit democratico” (almeno ampiamente
percepito) di questa istituzione, e il fatto che rappresenta i 27, non
la zona euro.
La sorveglianza tra pari in Consiglio
non ha funzionato bene in passato e potrebbe non funzionare nemmeno
nel quadro rafforzato del Patto di Stabilità e di Crescita che è previsto
in ogni caso. Le sanzioni (cioè non avere accesso a risorse del bilancio
UE, subire penalità, e così via) non possono essere progettate in
modo appropriato, perché non sono coerenti: quando sorge un problema
reale il paese non è punito, ma bensì riceve aiuto.
Le modalità del processo decisionale
dell’organismo che dovrebbe supervisionare la politica fiscale nazionale
(molto probabilmente il cosiddetto Eurogruppo) presumibilmente dovrebbero
essere un qualche tipo di maggioranza qualificata. Ma come si potrebbe
poi impedire a una maggioranza di paesi fiscalmente lassisti di concedere
aumenti del disavanzo? Questo già è accaduto nel 2003/4. Alla fine,
l’emissione di eurobond richiede l’istituzione degli Stati Uniti
d’Europa sulla politica di bilancio, per cui i cittadini di tutti i
paesi membri concordano in anticipo che i pagamenti delle imposte potrebbero
servire a sostenere altri Paesi e che i loro livelli di prestazioni
potrebbero essere ridotti perché altri paesi hanno pagato troppo ai
propri cittadini.
Tuttavia, anche così si può
dubitare che anche i migliori incentivi a livello statale riescano a
perseguire la solidità fiscale e una buona performance
economica della zona euro. L’evoluzione della crisi del debito ha dimostrato
che i paesi si muovono solo sotto il controllo dei mercati e l’aumento
dei costi di rifinanziamento dell’Italia ne ha fornito la prova ultima.
È sufficiente l’unione politica?
Chi propone un’unione politica per
rendere praticabili gli eurobond suppone che alcune modifiche
del trattato e accordi politici di alto livello sarebbero sufficienti
a garantire che i paesi membri attuino tutte le decisioni prese a livello
europeo (o meglio della zona euro). Tuttavia, questa non è una conclusione
scontata, come ha dimostrato l’esperienza di aggiustamento fiscale della
Grecia. Anche il governo più determinato non è stato in grado di attuare
le misure di austerità che si sapevano necessarie.
Ci sono profonde differenze tra i sistemi
politici degli Stati membri e il modo in cui le amministrazioni in realtà
lavorano. La Banca Mondiale fornisce un’utile banca dati di “indicatori
di governance“, che ci permette di confrontare i paesi in
base alla qualità delle loro amministrazioni e alla misura in cui lo
stato di diritto è realmente rispettato. Questi sono elementi chiave
per il funzionamento di una unione politica dell’Eurozona. Tuttavia,
anche una rapida occhiata a questi indicatori rivela che le differenze
sono così grandi che un’unione politica è improbabile che funzioni.
La tabella 1 mostra i tre più
rilevanti indicatori di governance, “efficacia del governo”,
“stato di diritto” e “controllo della corruzione”.
Un minimo standard comune su tutti e tre è necessario per garantire
che le decisioni comuni in materia di disavanzo massimo ammissibile
in ciascun paese siano effettivamente attuate, in modo che i contribuenti
dei paesi più forti possano essere certi che i necessari meccanismi
di applicazione effettivamente funzioneranno.
Tuttavia, i dati mostrano che c’è
una grande differenza tra i paesi “Core” e il “Club Med”
(Grecia, Italia, Portogallo e Spagna). In particolare la Grecia e l’Italia
mostrano delle performance particolarmente negative, anche rispetto
a Portogallo e Spagna, i cui standard sono ancora nettamente sotto la
media del centro dell’euro. Su quasi ogni indicatore, i dati sia per
la Grecia che per l’Italia sono più di due deviazioni standard al di
sotto della media dell’Eurozona.

Tabella 1. Indicatori di governance dell’Eurozona: Centro contro Club Med o Periferia Sud
Note: L'”efficacia del governo”
rappresenta la percezione della qualità dei servizi pubblici, la qualità
degli amministratori pubblici e il loro grado di indipendenza dalle
pressioni politiche, la qualità della formulazione e attuazione delle
politiche, e la credibilità dell’impegno del governo per queste politiche.
Il “Controllo della corruzione”
rappresenta la percezione della misura in cui viene esercitato il potere
pubblico per interessi privati, in entrambe le forme di piccola e grande
corruzione, così come “l’idea” dello stato da parte
delle élite e degli interessi privati.
Lo “Stato di diritto” rappresenta
la percezione della misura in cui gli operatori hanno fiducia e rispettano
le regole della società, e in particolare la qualità di esecuzione
dei contratti, i diritti di proprietà, la polizia e i tribunali, così
come la probabilità di reati e di violenza.
Fonte: WGI 2009, la Banca Mondiale
La figura sottostante fornisce una
conferma visiva della differenza tra il Centro e i paesi del Sud dell’Eurozona.
.png)
Queste differenze nella qualità della
governance, più di ogni problema tecnico, sono probabilmente la
ragione per cui l’elettorato del Nord Europa è scettico circa gli
Eurobond. Con queste differenze fondamentali nel funzionamento dei
diversi paesi membri, sarebbe in pratica impossibile condurre una politica
fiscale unitaria, anche se venisse creato un Ministro delle Finanze
della zona euro.
Conclusioni
Qualunque sia la variante, gli Eurobond
hanno senso solo in una unione politica, e anche allora solo quando
i livelli del debito sono bassi [1]. Quando si parte da livelli di indebitamento
così alti che i mercati sospettano un eccesso di debito, gli Eurobond
equivarrebbero a un grande trasferimento di rischio e genererebbero
forti aspettative che futuri accumuli di debito sarebbero trattati allo
stesso modo.
Il sostegno politico agli Eurobond
sembra essere in crescita anche negli Stati membri come la Germania
(i Socialdemocratici e i Verdi hanno espresso il loro sostegno), ma
solo perché l’idea suona bene a prima vista. Una volta che saranno
discusse le implicazioni fiscali di una proposta specifica, il sostegno
politico può svanire molto velocemente. Le probabilità che il Bundestag
tedesco a maggioranza costituzionale sottoscriva implicitamente 6.700
miliardi in euro di debito pubblico dell’Eurozona quando il debito tedesco
è “solo” circa 2.000 miliardi di euro sono davvero scarse.
Le differenze tra i sistemi politici
nazionali e la loro qualità di governance sono così grandi
che qualsiasi unione politica anche creata sulla carta in pratica non
potrebbe funzionare.
Riferimenti:
Ifo, What
will Eurobond cost?, Press
release, 17 agosto 2011.
De Grauwe, Paul, The European Central Bank
as a lender of last resort,
VoxEU.org, 18 agosto 2011.
Delpa, Jacques E Jakob von Weizsäcker, The Blue Bond Proposal, Breugel.org, 11 maggio 2011.
Gros, Daniel, The seniority conundrum:
Bail out countries but bail in private, short-term creditors?, VoxEU.org, 5 dicembre 2010.
Gros, Daniel, August 2011: The euro crisis
reaches the core, VoxEU.org,
11 agosto 2011.
Gros, Daniel e Stefano Micossi, Crisis management tools
for the euro-area, VoxEU.org,
30 settembre 2008.
Kopf, Christian, Restoring financial stability
in the euro area, CEPS
Policy Briefs, 2011.
Manasse, Paolo, My name is Bond, Euro Bond,
VoxEU.org, 16 dicembre 2010.
Suarez, Javier, A three-pillar solution
to the Eurozone crisis,
VoxEU.org, 15 agosto 2011.
Note:
[1] Il governo federale degli Stati
Uniti appena creato ha assunto il debito degli stati fondatori, perché
il debito era stato contratto nella lotta per una causa comune. Non
è certo questo il caso oggi in Europa.
* Questo lucido articolo è stato originariamente pubblicato in Voxeu.org e poi ripubblicato dagli amici di «Voci dall’estero», che ringraziamo per la traduzione, che abbiamo corretto qua e la.
* Daniel Gros is the Director of the Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brussels. Originally from Germany, he attended university in Italy, where he obtained a Laurea in Economia e Commercio. He also studied in the United States, where he earned his M.A. and PhD (University of Chicago, 1984). He worked at the International Monetary Fund, in the European and Research Departments (1983-1986), then as an Economic Advisor to the Directorate General II of the European Commission (1988-1990). He has taught at the European College (Natolin) as well as at various universities across Europe, including the Catholic University of Leuven, the University of Frankfurt, the University of Basel, Bocconi University, the Kiel Institute of World Studies and the Central European University in Prague.
Fonte: Il
mio nome è Bond, Eurobond
30.08.2011
CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte
CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALI UFFICIALI TELEGRAM:
Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg
Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie
Salute - https://t.me/CDCPiuSalute
Video - https://t.me/comedonchisciotte_video
CANALE UFFICIALE WHATSAPP:
Principale - ComeDonChisciotte.org