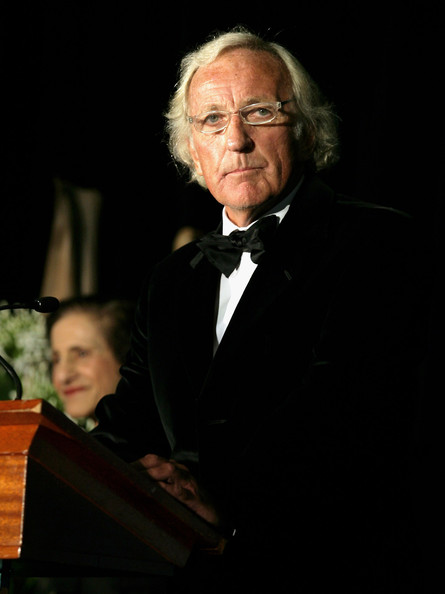PAYPAL: Clicca qui
STRIPE: Clicca qui
In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro conto
Titolare del conto: Come Don Chisciotte
IBAN: BE41 9674 3446 7410
BIC: TRWIBEB1XXX
Causale: Raccolta fondi
DI JOHN PILGER
johnpilger.com
Nel discorso di accettazione del premio australiano per i diritti umani, il Sydney Peace Prize, all’Opera House di Sydney, John Pilger descrive la “singolare caratteristica” del silenzio politico in Australia: come esso influisca sulla vita nazionale della sua patria e sul modo in cui gli Australiani vedono il mondo e sono manipolati da un grande potere “che parla attraverso un invisibile governo di propaganda che sottomette e limita il nostro immaginario politico per assicurarsi che noi siamo sempre in guerra – contro il nostro primo popolo [gli Aborigeni, n.d.t.] e contro chi cerca un rifugio, o in qualche paese altrui”.
Grazie a tutti per essere qui stasera, molte grazie alla città di Sydney e specialmente alla Sydney Peace Foundation per avermi assegnato il Sydney Peace Prize 2009. È un grande onore per me perché mi viene consegnato dal Paese da cui provengo.
Sono australiano della settima generazione. Un mio trisavolo approdò non lontano da qui l’8 novembre 1821. Ai piedi portava catene di 2 chili l’una. Si chiamava Francis McCarty. Era un Irlandese, giudicato colpevole del reato di ribellione e di “dichiarazioni illecite”. Nell’ottobre di quello stesso anno, una 18enne di nome Mary Palmer salì sul banco degli imputati nel carcere del Middlesex e fu condannata alla deportazione nel New South Wales vita natural durante. Il suo crimine era quello di rubare per sopravvivere. Soltanto il fatto che fosse incinta la salvò dalla forca. Era la mia trisnonna.
Nella foto: John Pilger
Dalla nave la portarono alla “Fabbrica Femminile” di Parramatta, una nota prigione dove ogni terzo lunedì del mese i galeotti maschi erano portati per il “giorno di corteggiamento” – un metodo di sviluppo sociale piuttosto disperato. Mary e Francis s’incontrarono così e si sposarono il 21 ottobre 1823.
Cresciuto a Sydney, di questo non sapevo nulla. Gli otto fratelli di mia madre usavano molto spesso la parola “origini”. Tu eri di “buone origini” o di “cattive origini”. Non si parlava del fatto che noi venivamo da “cattive origini” – che avevamo la cosiddetta “macchia”.
Un Natale, con la famiglia al completo, mia madre toccò il tema delle nostre origini criminali e una delle mie zie quasi ingoiò la sua dentiera. “Lasciali riposare in pace, Elsie!” disse. E così facemmo – finché, molti anni dopo, una mia ricerca a Dublino e Londra portò ad un film per TV che rivelò il completo orrore delle nostre “cattive origini”. Ci fu uno scandalo. “Tuo figlio”, scrisse mia zia Vera a Elsie “non è meglio di un maledetto comunista” e minacciò di non parlarci mai più.
Il silenzio australiano ha una caratteristica singolare
Da ragazzino scappavo di nascosto a La Perouse e stavo sulle dune di sabbia a guardare la gente che si diceva fosse estinta. Rimanevo a bocca aperta a guardare i bambini della mia età, che si diceva fossero sporchi e buoni a nulla. Alle scuole superiori lessi un libro del celebre storico australiano Russel Ward, che scrisse: “Oggi noi siamo civilizzati, loro no”. “Loro”, naturalmente, erano gli Aborigeni.
La mia vera educazione in Australia iniziò alla fine degli anni ’60 quando Charlie Perkins e sua madre, Hetti, che Charlie mi descrisse come regina del popolo Aranda, mi portarono all’accampamento aborigeno di Jay Creek nel Northern Territory. Hetti portava un grosso cappello nero ed era seduta davanti nella Ford Falcon che avevamo noleggiato. Quando arrivammo suggerì di buttar giù il cancello per entrare.
Non scorderò mai lo shock che mi provocò quel che vidi. Povertà. Malattie. Disperazione. La rabbia sottaciuta. Cominciai a riconoscere e capire il silenzio australiano.
Questa sera vorrei parlarvi di questo silenzio: come esso influenza la nostra vita nazionale, il nostro modo di vedere il mondo e il modo in cui siamo manipolati da un grande potere, che parla attraverso un invisibile governo di propaganda, che sottomette e limita la nostra capacità di pensare alla politica per assicurarsi che noi siamo sempre in guerra – contro il nostro primo popolo [gli Aborigeni, n.d.t.] e contro chi cerca un rifugio, o nel paese di qualcun altro.
Lo scorso luglio, il primo ministro Kevin Rudd disse così: “È importante per tutti noi qui in Australia ricordare che l’Afghanistan è stato una palestra dove i terroristi internazionali si sono addestrati, una palestra anche per i terroristi del sud-est asiatico, per rammentarci delle ragioni per cui siamo sul campo di battaglia e per riaffermare la nostra determinazione a restare impegnati in quella causa”.
Non c’è verità in questa dichiarazione. Equivale alla menzogna del suo predecessore John Howard, quando disse che Saddam Hussein possedeva armi di distruzione di massa.
Poco prima che Kevin Rudd facesse quell’affermazione, alcuni aerei americani bombardarono una festa di matrimonio in Afghanistan. Almeno sessanta persone furono annientate, inclusi gli sposi e diversi bambini. Quella era la quinta festa di matrimonio attaccata, nel nostro nome.
Il primo ministro pronunciò il suo discorso sul sagrato di una chiesa una domenica mattina. Nessun cronista gli fece domande scomode. Nessuno disse che la guerra era una frode: che iniziò per una vendetta degli americani dopo l’11 settembre, in cui nessun Afgano era stato implicato. Nessuno fece presente a Kevin Rudd che i nostri nemici dichiarati in Afghanistan sono uomini introversi appartenenti a tribù che non hanno alcuna bega con l’Australia e a cui non importa niente del sud-est asiatico e che vogliono soltanto che i soldati stranieri se ne vadano dal loro Paese.
E soprattutto, nessuno disse: “Primo Ministro, non esiste la guerra al terrore. È una bufala. Ma esiste una guerra di terrore creata da governi, incluso quello australiano, nel nostro nome”. Quella festa matrimoniale, Primo Ministro, è stata annientata da una tra le più evolute armi intelligenti, la bomba Hellfire [Fuoco infernale], che risucchia l’aria dai polmoni. In nostro nome.
Nel corso della prima guerra mondiale, il primo ministro britannico, Lloyd George, confidò all’editore del Manchester Guardian: “Se la gente veramente sapesse (la verità), la guerra finirebbe domani. Ma naturalmente non la sanno, e non la possono sapere.”
Cos’è cambiato? Molto infatti. Dato che la gente è diventata più consapevole, la propaganda si è fatta più sofisticata.
Uno dei fondatori della propaganda moderna è stato Edward Bernays, un Americano che credeva che al popolo in società libere si potesse mentire e che lo si potesse imbrigliare senza che se ne accorgesse. Inventò un eufemismo per propaganda, la chiamò “pubbliche relazioni”, o PR. “Quel che importa – disse – è l’illusione”. Come la conferenza stampa orchestrata per Kevin Rudd davanti a quella chiesa, quel che importa è l’illusione. I simboli dell’ANZAC [acronimo per indicare Australia and New Zealand Army Corps, o “Corpo d’armata di Australia e Nuova Zelanda”, ed è la giornata in memoria dei soldati delle forze armate caduti in battaglia, n.d.t.], sono sistematicamente manipolati a quel modo. Parate. Medaglie. Bandiere. Il dolore della famiglia di un soldato caduto. Servire nell’esercito, dice il primo ministro, è la più alta vocazione in Australia. Lo squallore della guerra, l’uccisione di civili non fanno testo. Quel che conta è l’illusione.
Lo scopo è quello di assicurarsi la nostra silente complicità in una guerra di terrore e nell’enorme incremento dell’arsenale militare australiano. Missili cruise a lungo raggio saranno puntati ai nostri vicini. Il governo Rudd e il Pentagono hanno indetto una gara per la costruzione di robots militari, che, si dice, faranno “il lavoro sporco” dell’esercito in “zone di combattimento urbane”. Quali zone di combattimento urbane? Quale lavoro sporco?
Silenzio.
“Confesso – scrisse Lord Curzon, vicere dell’India più di un secolo fa – che le nazioni non sono che pezzi su un scacchiera su cui si gioca una grande partita per il dominio del mondo”.
Noi Australiani siamo al servizio di questa Grande Partita da molto tempo. I giovani che ogni aprile si drappeggiano con la bandiera di Gallipoli capiscono che sono cambiate soltanto le bugie? – che glorificare i sacrifici di sangue in guerre coloniali non fa altro che prepararci alla prossima guerra?
Quando il primo ministro Robert Menzies mandò i soldati australiani in Vietnam negli anni sessanta, li descrisse come “una squadra di addestramento”, richiesta dal sofferente governo di Saigon. Era una bugia. Un ufficiale superiore del Dipartimento per gli Affari Esterni scrisse la verità segreta: “Per quanto abbiamo ribadito pubblicamente che la nostra assistenza era stata data in risposta ad un invito del governo sudvietnamita, la nostra offerta era in effetti stata fatta a seguito ad una richiesta del governo degli Stati Uniti.”
Due versioni. Una per noi, una per loro.
Menzies parlava incessantemente della “spinta verso il basso del comunismo cinese”. Cosa è cambiato? Davanti alla chiesa Kevin Rudd disse che eravamo in Afghanistan per fermare un’altra spinta verso il basso. Due menzogne.
Durante la guerra del Vietnam, il Ministero degli Affari Esteri fece una rara lamentela a Washington. Denunciò che gli Inglesi conoscevano meglio gli obiettivi dell’America che non i loro fedeli alleati australiani. Un assistente segretario di stato replicò: “Dobbiamo informare gli Inglesi per tenerceli buoni – disse – voi siete con noi, comunque vada”.
A quante guerre ancora dobbiamo essere trascinati dentro prima di rompere il silenzio?
Quante follie ancora dobbiamo sopportare noi, come popolo, prima d’iniziare il lavoro di raddrizzare i torti nel nostro Paese?
“È ora di gridare dai tetti del mondo – diceva Kevin Rudd quand’era all’opposizione – [che] nonostante l’Iraq, l’America è una travolgente forza del bene nel mondo [e] io non vedo l’ora di lavorare con la grande democrazia americana, l’arsenale della libertà…”
Dalla seconda guerra mondiale l’arsenale della libertà ha rovesciato 50 governi, democrazie incluse, e soffocato circa 30 movimenti di liberazione. Milioni di persone nel mondo sono state costrette a lasciare le loro case e assoggettate a sanzioni devastanti. Bombardare è tanto americano quanto la torta di mele.
Nell’accettare il Premio Nobel per la Letteratura nel 2005, Harold Pinter pose questa domanda: “Perché la sistematica brutalità, le grandi atrocità, la crudele repressione del pensiero indipendente della Russia stalinista sono ben risapute in Occidente mentre le azioni criminali americane non sono mai successe? Niente è mai successo. Persino mentre stava succedendo non succedeva. Non importava. Non interessava”.
In Australia ci hanno esercitati a rispettare questo tipo di censura per omissione. Un’invasione non è un’invasione se siamo “noi” a farla. Il terrore non è terrore se siamo “noi”a procurarlo. Un crimine non è un crimine se siamo “noi” a commetterlo. Non è successo. Anche mentre succedeva non è successo. Non importava. Non interessava.
Nell’arsenale della libertà ci sono due categorie di vittime. Gli innocenti uccisi nelle Torri Gemelle erano vittime che pesavano. Gli innocenti uccisi dalle bombe Nato in Afghanistan sono vittime irrilevanti. Gli Israeliani hanno un peso. I Palestinesi non ne hanno. La cosa si fa complessa. I Curdi che si ribellarono a Saddam Hussein avevano un peso. Ma i Curdi che si ribellano al regime della Turchia non ne hanno. La Turchia è membro della Nato. La Turchia fa parte dell’arsenale della libertà.
Il governo Rudd giustifica le sue proposte di spendere miliardi in armamenti riferendosi a quello che il Pentagono chiama un “arco di instabilità” che si estende in tutto il mondo. Pare che i nostri nemici siano dappertutto – dalla Cina al Corno d’Africa. È vero che un arco d’instabilità si estende per tutto il globo, è quello fomentato dagli Stati Uniti. L’aviazione americana lo definisce “dominio totale”. Più di 800 basi americane sono pronte ad entrare in guerra.
Queste basi proteggono un sistema che permette all’uno per cento dell’umanità di controllare il 40 per cento della ricchezza; un sistema che tira fuori dai guai una banca con 180 miliardi di dollari – che basterebbero ad eliminare la malnutrizione nel mondo, dare un’educazione ad ogni bambino e provvedere acqua e igiene per tutti, oltre ad invertire la diffusione della malaria. L’11 settembre 2001 le Nazioni Unite dichiararono che in quel giorno 36.615 bambini erano morti di povertà. Ma questa non era una notizia.
Ai giornalisti e agli uomini politici piace dire che il mondo è cambiato a seguito degli attacchi dell’11 settembre. In effetti, per quei Paesi sotto attacco da parte dell’arsenale della libertà non è cambiato nulla. Cosa è cambiato non fa notizia.
A detta del grande informatore Daniel Ellsberg, negli USA c’è stato un colpo di stato militare ed ora il Pentagono la fa da padrone in ogni settore che riguarda la politica estera.
Non importa chi sia presidente – George Bush o Barack Obama. Infatti, Obama ha inasprito le guerre di Bush e ha iniziato una sua guerra in Pakistan. Come Bush, sta minacciando l’Iran, un Paese che Hillary Clinton ha dichiarato di esser pronta ad “annientare”. Il crimine dell’Iran è la propria indipendenza. Essendosi sbarazzato del tiranno beniamino dell’America, lo Shah, l’Iran è il solo stato musulmano ricco di risorse fuori dal controllo degli Stati Uniti. Non occupa la terra di nessuno e non ha attaccato nessun paese – al contrario di Israele, che ha testate nucleari e domina e divide il medio oriente per conto dell’America.
Non ci dicono queste cose in Australia. Sono tabù. Al contrario, acclamiamo diligentemente l’illusione di Obama, la celebrità globale, il sogno commerciale. Come Calvin Klein, il marchio Obama offre il brivido di una nuova immagine consona alla sensibilità dei liberali, se non dei bambini afgani che bombarda.
Questa è propaganda moderna in azione, che usa una specie di razzismo all’inverso allo stesso modo in cui adopera identità di genere e classe sociale come strumenti di seduzione. Nel caso di Barack Obama cosa importa non è la sua razza o le sue belle parole, ma la classe e il potere che lui serve.
In un articolo per la rivista The Monthly dal titolo “Fiducia nella Politica”, Kevin Rudd scrisse così riguardo ai rifugiati: “Il richiamo biblico di prendersi cura dello straniero tra di noi è chiaro. La parabola del Buon Samaritano non è che una delle molte che parlano del corretto modo di comportarsi con uno straniero vulnerabile tra di noi… Non dobbiamo mai dimenticarci che la ragione per cui esiste una convenzione tra le Nazioni Unite sulla protezione dei rifugiati è in gran parte dovuta all’orrore dell’Olocausto, quando l’Occidente (Australia inclusa) voltava le spalle al popolo ebraico dell’Europa occupata che chiedeva asilo”.
Paragonate questo passaggio alle parole che Rudd pronunciò poco tempo fa: “Non chiedo assolutamente scusa – ha detto – per la linea dura che ho preso verso l’immigrazione illegale in Australia… una linea dura contro chi chiede asilo”.
Non ne abbiamo abbastanza di questo tipo d’ipocrisia? L’uso del termine “immigrato illegale” è falso e vigliacco. Le poche persone che arrivano con difficoltà sulle nostre rive non sono illegali. La legge internazionale è chiara – sono legali. Eppure Rudd, come Howard, gli manda contro la marina e li spedisce in quello che a tutti gli effetti è un campo di concentramento su Christmas Island. Che vergogna. Immaginatevi una nave carica di bianchi che sta fuggendo da una catastrofe per poi essere trattata così.
La gente in quei barconi dimostra quel coraggio, quel fegato che gli australiani dicono di ammirare. Ma questo non basta al Buon Samaritano di Camberra, dato che si comporta allo stesso modo dei bigotti che, come ha scritto nel suo articolo, “voltavano le spalle al popolo ebraico dell’Europa occupata”.
Perché tutto questo non è scandito chiaramente? Perché lasciare che parole ambigue come “protezione dei confini” diventino la valuta di una crociata mediatica contro altri esseri umani, che ci dicono di dover temere, principalmente musulmani? Perché i giornalisti, il cui mestiere dovrebbe essere quello di raccontare le cose come stanno, diventano complici di questa campagna?
Dopotutto, l’Australia ha avuto alcuni dei più aperti e coraggiosi giornali al mondo. Gli editori rappresentavano le persone, non il potere. Il Sydney Monitor, dell’editore Edward Smith Hall, smascherò i modi dittatoriali del Governatore Darling ed aiutò a portare la libertà di parola nella colonia. Oggigiorno, la maggior parte dei media australiani parla per il potere, non per la gente.
Sfogliate le pagine dei maggiori quotidiani; guardate le notizie in TV. Così come protezione dei confini abbiamo protezione della mente. C’è un consenso su ciò che leggiamo, vediamo e ascoltiamo; su come dovremmo gestire la nostra politica o vedere il resto del mondo. Frontiere invisibili tengono fuori fatti e opinioni che non sono accettabili.
Effettivamente questo è un sistema grandioso, che non richiede istruzioni, no autocensure. I giornalisti sanno cosa non fare. Naturalmente, adesso che la censura è diretta e cruda. SBS (Special Broadcasting Service, Australia) ha proibito ai suoi giornalisti di usare la frase “terra palestinese” per parlare della Palestina illegalmente occupata. Devono definire quei territori come “l’oggetto di negoziazione”. È come se qualcuno si prendesse la vostra casa a mano armata e il giornalista della SBS lo descrivesse il fatto come “l’oggetto di negoziazione”.
In nessun altro Paese democratico la discussione pubblica riguardante la brutale occupazione della Palestina è così limitata come in Australia. Siamo coscienti della vastità dei crimini contro l’umanità commessi a Gaza? Ventinove membri di una famiglia – bambini, nonne – sono abbattuti, fatti saltare per aria, sepolti vivi, la loro casa livellata dalle ruspe. Leggetevi il rapporto, scritto da un eminente giudice israeliano, Richard Goldstone.
Quelli che parlano per l’arsenale della libertà stanno lavorando alacremente per insabbiare il resoconto delle Nazioni Unite. Perché soltanto una nazione, Israele, ha il “diritto di esistere” in Medio Oriente. Solo una nazione ha il diritto di aggredire gli altri. Solo una nazione ha l’impunità nell’esercitare un regime di discriminazione razziale con l’approvazione del mondo occidentale, e col primo e vice primo ministro australiani prostrati in adulazione dei suoi leader.
In Australia, qualsiasi digressione da questa tacita regola, da questa impunità, si attira una vile campagna di insulti e intimidazioni personali normalmente associata ad una dittatura. Ma noi non siamo una dittatura. Siamo una democrazia.
Lo siamo davvero?
O siamo piuttosto una murdochrazia.
Rupert Murdoch ha stabilito l’agenda di guerra dei media poco prima dell’invasione dell’Iraq quando disse: “Ci saranno danni collaterali. E se vogliamo essere brutali a questo riguardo, è meglio farli subito”.
Più di un milione di persone sono state ammazzate in Iraq a causa di quell’invasione: “una vicenda – secondo uno studio – più funesta del genocidio del Rwanda”. Nel nostro nome. Siamo coscienti di questo in Australia?
Tempo fa camminavo per Mutanabi Street, a Bagdad. L’atmosfera era bellissima. La gente sedeva nei bar, leggeva. Musicisti suonavano. Poeti recitavano. Pittori dipingevano. Questo era il cuore culturale della Mesopotamia, della grande civiltà cui noi in Occidente dobbiamo moltissimo, inclusa la scrittura. La gente con cui parlavo era Sunnita, Shiita, ma si dichiaravano Iracheni. Erano colti e orgogliosi.
Oggi sono o fuggiti o morti. Matanabi Street è stata distrutta. A Bagdad i grandi musei e biblioteche sono depredati. Le università saccheggiate. E persone che un tempo s’incontravano per un caffè, e si sposavano tra loro, sono state trasformate in nemici. “Costruiamo la democrazia” dissero Howard, Bush e Blair.
Una delle opere teatrali di Harold Pinter che prediligo è “Party Time”. Si svolge in un appartamento in una città come Sydney. È in corso una festa. Gli invitati bevono buon vino e mangiano tartine. Sembrano felici. Chiacchierano e sorridono affabilmente. Sono eleganti e sicuri di sé.
Ma qualcosa succede fuori per strada, qualcosa di terribile, opprimente, ingiusto, qualcosa di cui i partecipanti alla festa sono corresponsabili.
C’è un fugace senso di disagio, un silenzio, prima che il chiacchiericcio e le risate riprendano.
Quanti di noi vivono in quell’appartamento?
Lasciatemelo dire in un altro modo. Conosco una bravissima giornalista israeliana che si chiama Amira Hass. Lei è andata a vivere e a corrispondere da Gaza. Le ho chiesto perché lo ha fatto. Mi ha spiegato che sua madre, Hannah, da un vagone bestiame, era stata incolonnata e avviata a passo di marcia verso il campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen quando vide un gruppo di donne tedesche che guardavano i prigionieri, li guardavano soltanto, senza parlare, in silenzio. Sua madre non dimenticò mai quello che chiamò questo deprecabile “guardare obliquamente”.
Io credo che se gestissimo le vicende umane con giustizia e coraggio, cominceremmo a dare un senso al nostro mondo. Allora, e solo allora, potremo progredire.
Tuttavia, se applichiamo la giustizia in Australia diventa complicato, vero? Perché allora saremmo obbligati a rompere il nostro silenzio più grande – a non più “guardare obliquamente” nel nostro stesso Paese.
Negli anni ’60, quando per la prima volta mi recai in Sud Africa per scrivere sull’apartheid, fui accolto da persone perbene, liberali, il cui silenzio complice era però alla base di quella dittatura. Mi dissero che australiani e sudafricani bianchi avevano molto in comune, ed avevano ragione. Quelle brave persone di Johannesburg potevano vivere entro pochi chilometri da una comunità chiamata Alexandra, dove mancavano i servizi primari, dove i bambini erano afflitti da malattie. Ma loro guardavano obliquamente, e non facevano nulla.
In Australia, la nostra indifferenza è diversa. Ci siamo specializzati nel dividere e dominare, dando sostegno a quegli Australiani neri che ci dicono quel che vogliamo sentire. In conferenze professionali i loro discorsi di base sono applauditi, specialmente quando incolpano il loro stesso popolo, fornendoci le scuse di cui abbiamo bisogno. Creiamo comitati e assemblee gestiti da gente piacevole, liberale, come la moglie del primo ministro, ma non cambia niente.
Certamente a noi non piacciono paragoni con il Sud Africa dell’apartheid. Ciò spezza il silenzio australiano.
Verso la fine dell’apartheid, i Sudafricani neri venivano imprigionati alla media di 851 ogni 100.000 persone. Oggi, gli Australiani neri sono imprigionati ad una media nazionale cinque volte più alta. L’Australia occidentale imprigiona gli aborigeni otto volte di più del regime dell’apartheid.
Nel 1983, Eddie Murray fu ucciso in una cella della polizia a Wee Waa, nel New South Wales, da “persona o persone sconosciute”. Così asserì il medico legale. Eddie era una stella nascente del rugby. Ma era nero e dovevano dargli una lezione. I genitori di Eddie, Arthur e Leila Murray, promossero una delle più tenaci e coraggiose campagne per ottenere giustizia che io abbia mai visto. Si confrontarono con le autorità. Dimostrarono compostezza, pazienza e competenza. E non si dettero mai per vinti.
Quando nel 2003 Leila morì, scrissi un tributo per il funerale. La descrissi come un’eroina australiana. Arthur si sta ancora battendo per ottenere giustizia. Ha più di sessant’anni. È un anziano rispettato, un eroe. Qualche mese fa la polizia di Narrabi gli offrì un passaggio a casa, ma gli fecero invece fare una corsa violenta a bordo del loro bullwagon. Lui finì in ospedale, ferito e malconcio. È così che sono trattati gli eroi australiani.
La settimana stessa in cui la polizia si comportò a quel modo – come fa quasi ogni giorno con gli australiani neri – Kevin Rudd disse che il suo governo, e cito: “non ha un’idea chiara di quel che succede sul terreno” nell’Australia degli Aborigeni.
Quanta informazione deve reperire il primo ministro? Quante idee? Quanti comunicati? Quante commissioni reali? Quante inchieste? Quanti funerali? Non lo sa che a livello internazionale l’Australia fa parte di una “lista nera” per non aver eradicato il tracoma, una malattia evitabile associata alla povertà, che colpisce i bambini aborigeni rendendoli ciechi?
Nell’agosto di quest’anno le Nazioni Unite ancora una volta hanno segnato l’Australia con lo stesso marchio di vergogna riservato al Sud Africa. In parole povere, noi discriminiamo in base alla razza. Questa volta le Nazioni Unite hanno denunciato il cosiddetto “intervento”, la campagna di diffamazione ai danni delle comunità aborigene iniziato dal governo Howard nel Northern Territory consistente in accuse di schiavitù sessuale e pedofilia in un “numero inconcepibile” di casi, secondo il ministro per gli affari indigeni.
Nel maggio dell’anno scorso dati ufficiali furono resi noti, e quasi ignorati.
Su 7433 bambini aborigeni esaminati dai dottori, furono riportati alle autorità 39 casi di sospetto abuso. Di questi, un massimo di quattro possibili casi furono identificati. Alla faccia del “numero inconcepibile” di casi. Naturalmente l’abuso di minori esiste in Australia, sia tra i neri che tra i bianchi, la differenza sta nel fatto che nessun soldato è piombato sulle periferie di North Shore, nessun genitore bianco allontanato con la forza, nessun ufficio “bianco” del welfare è stato messo in quarantena. Che cosa hanno trovato, i dottori già lo sapevano, cioè che i bambini aborigeni sono sì a rischio, ma per effetto della povertà estrema e per il diniego di risorse, e questo in uno dei Paesi più ricchi al mondo.
Miliardi di dollari sono stati spesi – non per lastricare strade o costruire case – ma nel condurre una guerra di attrito a livello legale contro le comunità nere. Ho intervistato un capo aborigeno che si chiama Puggy Hunter. Aveva una ventiquattrore rigonfia ed era seduto, con la testa fra le mani, nel caldo dell’Australia occidentale.
Gli dissi: “Sei sfinito!”
Replicò: “Guarda, ho passato la maggior parte della mia vita in riunioni, a battermi con avvocati, a invocare il nostro diritto di nascita. Sono proprio stanco da morire, amico”. Morì poco tempo dopo, quarantenne.
Kevin Rudd ha chiesto formalmente scusa ai Primi Australiani. Ha usato belle parole. Per molti aborigeni, che danno valore al processo di riparazione, le scuse erano molto importanti. Il Sydney Morning Herald ha pubblicato un editoriale molto onesto. Descriveva l’atto di scusa come “un pezzo di relitto politico” che “il governo Rudd ha fatto presto a rimuovere… in modo da rispondere ai bisogni emotivi di parte del suo elettorato”.
Dal giorno delle scuse, la povertà tra gli Aborigeni è peggiorata. Il programma abitativo promesso è un triste scherzo. Né si è colmato alcun tipo di divario. Al contrario, il governo federale ha minacciato le comunità del Northern Territory che se non avessero consegnato i loro preziosi contratti di locazione, sarebbero stati negati loro i servizi primari che noi, nell’Australia bianca, diamo per scontati.
Negli anni ’70 alle comunità aborigene erano stati concessi i diritti a vaste estensioni di terra nel Northern Territory, e John Howard si diede da fare per riprenderseli con la corruzione e la prepotenza. Il governo laburista sta facendo lo stesso. Vedete, ci sono affaroni da farsi. Il Northern Territory è straordinariamente ricco di minerali, in special modo di uranio. Le terre degli aborigeni sono perfette per scaricarci scorie radioattive. Si tratta di affari d’oro, e le ditte straniere ne vogliono far parte.
È il proseguimento del lato più oscuro della storia della nostra colonizzazione: l’estorsione della terra altrui.
Dove sono le voci autorevoli del dissenso? Dove sono i legali più prestigiosi? Dove sono quelli che tra i media ci ripetono in continuazione quanto siamo imparziali?
Silenzio.
Ma non ascoltiamolo questo loro silenzio. Elogiamo invece quegli Australiani che non stanno in silenzio, che non guardano obliquamente– quelli come Barbara Shaw e Larissa Behrendt, e i capi della comunità Mutitjulu con il loro tenace avvocato George Newhouse, e Chris Graham, l’impavido editore del National Indigenous Times, e Michael Mansell, Lyle Munro, Gary Foley, Vince Forrester e Pat Dodson, e Arthur Murray.
Commemoriamo lo storico dell’Australia Henry Reynolds, che con coraggio e verità si oppose ai sostenitori della supremazia bianca che si atteggiano ad accademici e giornalisti. E i giovani che chiusero il campo di prigionia di Woomera e che poi si confrontarono coi teppisti politici che occuparono Sydney durante l’Apec Day di due anni fa. E il bravissimo Ian Thorpe, il grande nuotatore, la cui voce alzata contro “l’intervento” non ha ancora trovato un’eco tra gli adulati eroi sportivi in un Paese in cui il divario tra impianti sportivi ed opportunità per bianchi e per neri si è solo colmato impercettibilmente.
I silenzi possono essere spezzati, se lo vogliamo. In uno dei più grandi poemi in lingua inglese, Percy Shelley scrisse:
Alzatevi come leoni dopo il sonno
In numero incalcolabile
Scrollate le catene a terra come rugiada
Che cadde su di voi mentre dormivate
Voi siete molti – loro pochi.
Ma bisogna fare in fretta. Sta compiendosi un mutamento storico; le grandi democrazie occidentali si stanno muovendo verso un corporativismo. La democrazia è diventata un piano d’impresa, con la fine di ogni attività umana, ogni sogno, ogni decenza, ogni speranza. I principali partiti parlamentari sono ora dediti alle stesse politiche economiche – socialismo per i ricchi, capitalismo per i poveri – e la stessa politica estera volta a servire la guerra infinita.
Questa non è democrazia. È l’equivalente politico di ciò che McDonalds è per il cibo.
Come cambiare? Cominciamo a guardare oltre gli stereotipi e i cliché che ci rifilano come notizie. Tom Paine ci ha messi in guardia molto tempo fa che se ci fosse negata la conoscenza critica, noi dovremmo assaltare quello che lui chiamò la Bastiglia delle parole.
Tom Paine non aveva Internet, ma Internet non basta.
Abbiamo bisogno di una glasnost australiana, la parola russa dell’era di Gorbachov, che in sostanza significa risveglio, trasparenza, diversità, giustizia: a cui io aggiungerei disobbedienza.
È stato Edmond Burke a definire la stampa come il Quarto Potere. Io propongo di avere un Quinto Potere per il popolo, che controlli, dissezioni e contrasti le notizie ufficiali. In ogni redazione, in ogni collegio mediatico, bisogna mettere alla prova gli insegnanti di giornalismo e i giornalisti stessi circa il ruolo che svolgono negli spargimenti di sangue, nell’ingiustizia e nel silenzio che così spesso fanno passare per normali.
Non è il pubblico il problema; è vero, a qualcuno non importa niente – ma a milioni sì, come vedo dalle reazioni ai miei film. Cosa vuole la gente è essere partecipe – avere la percezione che le cose sono importanti, che niente è immutabile, che la disoccupazione tra i giovani e la povertà tra gli anziani sono cose incivili e sbagliate. Ciò che terrorizza gli agenti del potere è il risveglio del popolo che ritrovi la consapevolezza; che scopra che c’è un seme sotto la neve.
Questo sta già succedendo nei paesi latino americani dove gente comune ha scoperto una fiducia in se stessa che non sapeva di avere. Dovremmo unirci a loro prima che la nostra libertà di parola ci sia tacitamente sottratta e il vero dissenso sia bandito per legge mentre i poteri della polizia si espandono.
“La lotta del popolo contro il potere – scrisse Milan Kundera – è la lotta della memoria contro l’oblio”.
Abbiamo molto di cui essere orgogliosi in Australia – se soltanto lo sapessimo e festeggiassimo. Da quando Francis McCarty e Mary Palmer approdarono qui, abbiamo progredito soltanto perché la gente si fece sentire, soltanto perché le suffragette si ribellarono, soltanto perché i minatori di Broken Hill ottennero la prima settimana di 35 ore al mondo, soltanto perché pensioni, paga base e assegni familiari videro la luce qui nel New South Wales.
Nel corso della mia vita l’Australia è diventata uno dei posti più culturalmente vari al mondo, ed è accaduto più o meno pacificamente. È un successo notevole – fino a che cerchiamo quelli la cui civiltà australiana non è quasi mai stata riconosciuta, il cui genio per sopravvivenza, la cui generosità e la cui indulgenza sono state raramente motivo di orgoglio. Eppure restano, come scrisse Henry Reynolds, il mormorìo nei nostri cuori. Perché essi sono cìò che ci rende unici.
Credo che la chiave per il rispetto di noi stessi, il nostro retaggio per le future generazioni sia l’integrazione e il risarcimento dei Primi Australiani. In parole povere, giustizia. Non c’è mistero riguardo a cosa si deve fare. Il primo passo è un trattato che garantisca i diritti universali alla terra e la spartizione equa delle risorse di questo paese.
Soltanto allora potremo risolvere, insieme, questioni come salute, povertà, abitazioni, istruzione, occupazione. Soltanto allora potremo sentire un orgoglio che non proviene da bandiere, o da guerre. Soltanto allora potremo diventare una Nazione veramente indipendente, capace di parlare di ragionevolezza e di giustizia nel mondo, ed essere ascoltati.
John Pilger
Fonte: www.johnpilger.com
Link: http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=555
5.11.2009
Scelto e tradotto per www.comedonchisciotte.org da GIANNI ELLENA
CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte
CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALI UFFICIALI TELEGRAM:
Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg
Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie
Salute - https://t.me/CDCPiuSalute
Video - https://t.me/comedonchisciotte_video
CANALE UFFICIALE WHATSAPP:
Principale - ComeDonChisciotte.org