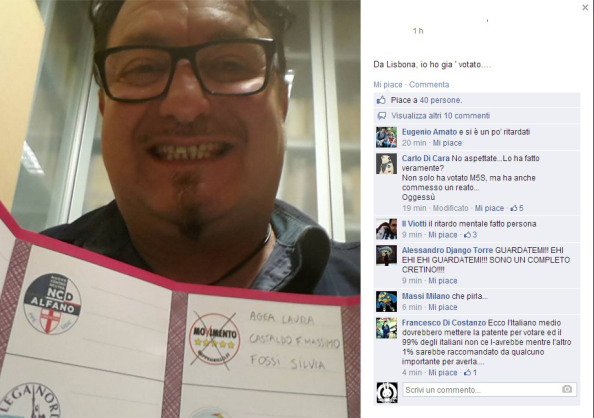PAYPAL: Clicca qui
STRIPE: Clicca qui
In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro conto
Titolare del conto: Come Don Chisciotte
IBAN: BE41 9674 3446 7410
BIC: TRWIBEB1XXX
Causale: Raccolta fondi
DI AGENOR
Le grandi strategie sono sempre composte da una sequenza di piccole iniziative e il quadro finale diventa visibile solo quando tutti i singoli pezzi del puzzle sono stati inseriti al posto giusto. La divisione in singole iniziative permette di focalizzare le discussioni su aspetti minori, senza sottoporre la grande strategia al vaglio dell’opinione pubblica o del dibattito parlamentare. Le grandi strategie sovranazionali, poi, hanno anche il vantaggio di limitare il dibattito oltre che alle singole misure anche a specifiche questioni locali, interne ai singoli paesi. Il disegno strategico di fondo non può essere contestato perché non è reso esplicito, non è sottoposto a dibattito e supera i confini delle competenze nazionali. Esso rimane quindi perfettamente al riparo dal processo democratico.
Uno di questi grandi disegni strategici che si sta realizzando in questi anni è la trasformazione dello stato sociale e del mercato del lavoro in Europa. Il cambio di paradigma fu dichiarato vent’anni fa dall’OCSE: passare dall’attivismo dello stato in economia per promuovere la piena “occupazione” alle politiche liberiste e mercantiliste per promuovere la piena “occupabilità”. Destra e sinistra in tutti i paesi si sono egualmente spese senza grandi distinzioni, in Italia come in Europa, per applicare il nuovo paradigma. Come tutte le grandi strategie, anche questa è composta da una sequenza di misure specifiche e ha un preciso modello di riferimento.
Il primo punto è il contenimento dei salari. È fondamentale che livello dei salari sia basso per mantenere competitivo il sistema produttivo. L’esigenza di essere più competitivi e di tirare un po’ tutti la cinghia in tempi di crisi sono le giustificazioni tipiche per far accettare questo contenimento. Come ben sappiamo questa esigenza diventa più pressante quando non si dispone del meccanismo del tasso di cambio. In altre parole, col cambio fisso il salario deve diventare flessibile. Nella zona euro abbiamo deciso di sostituire il tasso di cambio come meccanismo di aggiustamento degli squilibri esterni con il licenziamento e l’abbassamento dei salari. La riduzione dei salari nel settore pubblico si può fare per decreto (per ridurre il salario in termini reali, basta anche congelarlo in termini nominali, come spesso avviene), nel settore privato si ricorre alla decentralizzazione della contrattazione collettiva a livello di singola azienda. In quel modo il potere negoziale del singolo lavoratore è drasticamente ridotto. L’abbassamento dei salari, in generale, è facilitato dalla maggiore possibilità di licenziamento e dalla maggiore concorrenza per ottenere un posto di lavoro.
Subito dopo viene la ben nota questione della flessibilità, ovviamente flessibilità in uscita, come si chiama in linguaggio tecnico la possibilità di licenziare più facilmente. Si tratta di ridurre tutto il sistema di protezioni giuridiche che rendono difficile licenziare un lavoratore. Come si fa a rendere questo accettabile? Prima si colpisce una categoria, e dopo si scatena la classica guerra fra poveri: settore pubblico contro privato, giovani contro anziani, donne contro uomini, nord contro sud o est contro ovest, a seconda del paese. La giustificazione che accompagna questa misura è tipicamente quella di un’istanza di giustizia, modernità, e maggiore efficienza in tempi di crisi.
In Italia ce ne è voluto, ma alla fine dopo tanti tentativi l’Articolo 18 è stato abbattuto. Il Jobs Act ha sostanzialmente – anche se non formalmente – fatto sparire il concetto di contratto a tempo indeterminato, in quanto questo tipo di contratto ha perso tutte le tutele che lo rendevano effettivamente tale. Avendo così drasticamente penalizzato una parte dei lavoratori, nel settore privato, è stato poi facile convincerli che la colpa è di quegli altri, quelli del pubblico che sono più tutelati. Quindi anche loro adesso chiedono a gran voce di eliminare i “privilegi” del settore pubblico. Così pian piano si realizza la flessibilità in uscita per tutti. A titolo di esempio, nel paese modello per le recenti riforme del lavoro, la Spagna, ormai il 28% dei nuovi contratti ha una durata inferiore a 7 giorni: assunzione il lunedì mattina, licenziamento il venerdì sera, e poi si ricomincia il lunedì successivo.
Il terzo cardine è la mobilità della forza lavoro. Una volta licenziati, i disoccupati-potenziali-lavoratori sono comunque una risorsa utilizzabile altrove, quindi è utile facilitarne lo spostamento verso le zone in cui ce n’è più bisogno. Perché questo avvenga è necessario che ci sia un perfetto coordinamento dei servizi pubblici per l’impiego, non a caso una delle priorità stabilite in quasi tutti i paesi. I servizi pubblici per l’impiego, da centri di raccordo della domanda e dell’offerta a livello locale, devono diventare nodi di un’unica grande rete trans-europea che permetta il ricollocamento rapido di manodopera inutilizzata in un paese verso quello in cui ce n’è maggiormente bisogno. Anche qui la giustificazione è semplice: maggiore integrazione europea e maggiori opportunità di lavoro per chi non ce l’ha più.
Il quarto punto, anch’esso cruciale, è il mantenimento o la formazione di competenze adeguate a rendere “occupabile” il disoccupato-potenziale-lavoratore. Nessuno vuole un lavoratore che dopo anni d’inattività non è più capace di utilizzare i nuovi macchinari o sistemi informatici, perché rimasto tecnologicamente indietro. Bisogna quindi formarlo, ovviamente non finanziandogli una continuazione degli studi, che potrebbe permettergli un salto qualitativo sul mercato del lavoro, ma cercando invece di mantenerne aggiornate le competenze tecniche e professionali tali da renderlo utilizzabile immediatamente: saper usare l’ultimo macchinario o la tecnologia più recente introdotta in azienda. Ovviamente, questo tipo di misura si può ben presentare come sostegno ai disoccupati per facilitare l’apprendimento di competenze utili nel mercato del lavoro. In questo modo ci si assicura che tutta la popolazione in età lavorativa sia costantemente formata, addestrata anche nei periodi in cui è disoccupata, e sempre disponibile per le esigenze della produzione.
Questa costruzione però non sta in piedi se le persone rimangono disoccupate per lunghi periodi, o se i contratti sono talmente brevi e i periodi di lavoro troppo scarsi per garantire un minimo livello di sussistenza. Ecco che quindi entra in gioco il pezzo fondamentale del puzzle: il reddito minimo. Esso deve essere veramente “minimo”, nel senso di non creare un disincentivo ad accettare qualunque offerta di lavoro, anche la meno appetibile. Esso deve poi essere “condizionato”, cioè immediatamente revocabile nel caso di rifiuto dell’offerta ricevuta o di mancata frequentazione del corso di aggiornamento. E poi il disoccupato deve ovviamente sempre essere reperibile dal centro per l’impiego, pena il decadimento dal reddito minimo.
Non c’è bisogno di grandi acrobazie per “vendere” il reddito minimo come una grande conquista sociale. Ciò che veramente lo caratterizza come strumento di un quadro ben più reazionario, invece, è l’insieme di condizionalità ad esso legate. Sarebbe tutt’altra cosa remunerare il lavoro nella giusta misura, in linea con la sua produttività, e garantire anche un salario minimo dignitoso a tutti. Come sarebbe tutt’altra cosa istituire un sistema pubblico di “impiego di ultima istanza”. Ma tutto questo ridarebbe al lavoratore un’autonomia, una dignità e una forza contrattuale che lo renderebbe molto meno ricattabile. La differenza fra salario minimo e reddito minimo sembra poco più di una questione semantica, e invece è la differenza fra dignità e dipendenza, fra libertà e schiavitù.
Il sugello su questo nuovo modello di stato sociale è poi la sempiterna riforma delle pensioni, che ritorna ad intervalli regolari. Il motivo di questa sua ricorrenza è la volontà di passare progressivamente a una privatizzazione del sistema pensionistico, riducendo sempre più quelle pubbliche finché il cittadino non ha più scelta. Nel nuovo modello di stato sociale il costo di supportare il lavoratore vale la pena finché questi è in età lavorativa e può essere utile, dopodiché diventa solo un peso. Per questo motivo si preferisce tagliare sulle pensioni per spendere un po’ di più in formazione professionale e nella sussistenza del disoccupato. Chi può permetterselo, accumulerà in età lavorativa una ricchezza finanziaria che gli possa permettere di mantenersi anche dopo; chi non ce la fa, una volta smesso di lavorare emigrerà dove la vita costa meno o finirà in povertà. Così si riducono i costi per il settore pubblico, cosa ormai richiesta anche da chi avrebbe interesse a non farlo.
Queste sono le singole iniziative, che prese singolarmente sono anche accettabili e giustificabili agli occhi dell’opinione pubblica, come progressi verso una società più giusta ed efficiente. Mettendole tutte insieme e facendo attenzione ai dettagli con cui queste misure vengono poi applicate, però, si può vedere come esse concorrano a formare un quadro diverso. Tutta la popolazione in età lavorativa deve essere sempre a disposizione del sistema produttivo, utilizzabile e scartabile secondo il bisogno, formata in quelle competenze direttamente richieste dalla produzione e mantenuta al livello di sussistenza nei periodi in cui non è occupata, ma ricattabile e sottoposta alla concorrenza per il posto di lavoro, cioè con scarso potere contrattuale nel momento in cui viene assunta. Il modello di riferimento è quello tedesco, completato un decennio fa dalle riforme Hartz, dal nome dell’ex-manager Volkswagen, Peter Hartz, consigliere del governo Schröder.
Non si può capire quello che sta succedendo in Europa senza conoscere le riforme Hartz e in particolare il pacchetto Hartz IV. E non si possono capire le riforme Hartz senza conoscere i cardini del pensiero ordoliberistatedesco. Esso si differenzia dal cosiddetto neo-liberismo di matrice anglosassone, e ne diventa una versione molto più estrema, in quanto considera come compito esplicito dello stato quello di assicurare il quadro politico necessario per il libero dominio del capitale sul lavoro. In pratica l’ordoliberismo è un liberismo truccato, in cui la tensione fra i due fattori di produzione è ancora più squilibrata perché lo stato interviene esplicitamente per risolverla in favore del capitale a scapito del lavoro.
La cosiddetta economia sociale di mercato di matrice tedesca è il modello economico che stiamo applicando in Europa, prevalentemente nella zona euro, dove il margine di manovra dei governi nazionali è molto più limitato. Il quadro strategico complessivo che sta venendo fuori è la trasposizione del modello sociale tedesco nel resto d’Europa, cioè la scientifica costruzione di un esercito industriale di riserva su scala europea.
Agenor
Fonte: www.asimmetrie.org
Link: http://www.asimmetrie.org/opinions/lesercito-europeo-di-riserva/
20.01.2016
CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte
CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALI UFFICIALI TELEGRAM:
Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg
Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie
Salute - https://t.me/CDCPiuSalute
Video - https://t.me/comedonchisciotte_video
CANALE UFFICIALE WHATSAPP:
Principale - ComeDonChisciotte.org