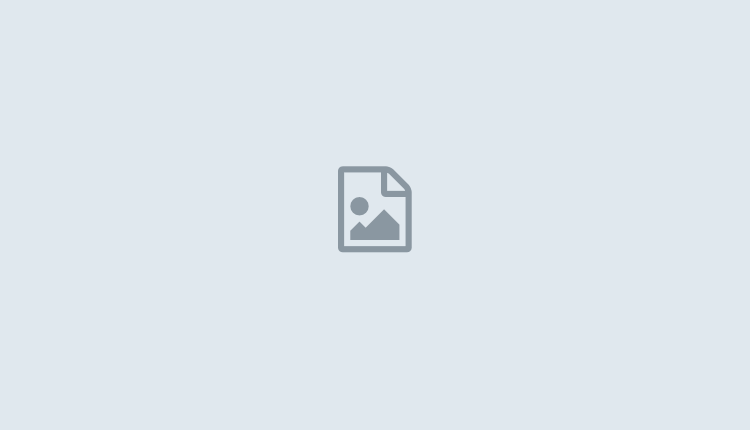DONA A COMEDONCHISCIOTTE.ORG PER SOSTENERE UN'INFORMAZIONE LIBERA E INDIPENDENTE:
PAYPAL: Clicca qui
STRIPE: Clicca qui
In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro conto
Titolare del conto: Come Don Chisciotte
IBAN: BE41 9674 3446 7410
BIC: TRWIBEB1XXX
Causale: Raccolta fondi
PAYPAL: Clicca qui
STRIPE: Clicca qui
In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro conto
Titolare del conto: Come Don Chisciotte
IBAN: BE41 9674 3446 7410
BIC: TRWIBEB1XXX
Causale: Raccolta fondi
Articolo rimosso su richiesta dell’autore, John Kleeves
ISCRIVETEVI AI NOSTRI CANALI
CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte
CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALI UFFICIALI TELEGRAM:
Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg
Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie
Salute - https://t.me/CDCPiuSalute
Video - https://t.me/comedonchisciotte_video
CANALE UFFICIALE WHATSAPP:
Principale - ComeDonChisciotte.org
CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte
CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALI UFFICIALI TELEGRAM:
Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg
Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie
Salute - https://t.me/CDCPiuSalute
Video - https://t.me/comedonchisciotte_video
CANALE UFFICIALE WHATSAPP:
Principale - ComeDonChisciotte.org