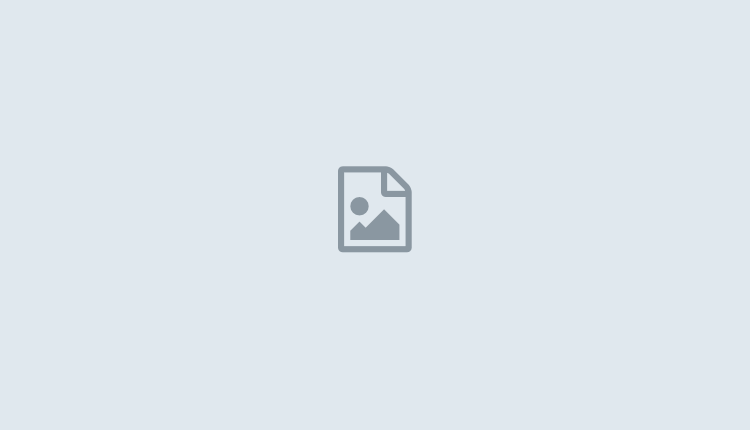PAYPAL: Clicca qui
STRIPE: Clicca qui
In alternativa, è possibile effettuare un bonifico bancario (SEPA) utilizzando il nostro conto
Titolare del conto: Come Don Chisciotte
IBAN: BE41 9674 3446 7410
BIC: TRWIBEB1XXX
Causale: Raccolta fondi

DI CESAR RENDUELES
Nodo50.org
Il ciberfeticismo – un sottoprodotto
della concezione mercificata del vincolo sociale – è l’ipotesi
secondo cui le tecnologie della comunicazione e le conoscenze ad essa
associata abbiano un significato neutro nel contesto sociale, istituzionale,
politico. Da questo feticismo provengono molti degli errori recenti
dei media, ad esempio quello di inserire le rivolte politiche
all’interno di categorie spurie, come cyber o twitter-rivoluzioni.
Nei giorni precedenti all’invasione
dell’Iraq, un quotidiano madrileno pubblicò una vignetta di grandi
dimensioni che illustrava i progressi tecnologici nell’equipaggiamento
del soldato statunitense. Il marine 2.0 era un cyborg
che i cittadini di Baghdad più fortunati avrebbero avuto l’opportunità
di ammirare prima di venire da lui arrostiti con l’uranio impoverito.
Si tratta di un luogo comune dei film di Hollywood. La più brutale
carneficina di un berretto verde risulta accettabile quando è filtrata
da occhiali per la visione notturna e da un mirino laser. Non è stato
sempre così. Prima della caduta dell’URSS, l’Occidente spesso rivendicava
lo sforzo analogico dell’individuo libero rispetto alla tecnologia
disumanizzante. In Rocky IV Balboa si allena in una stalla siberiana
mentre il suo rivale, il russo Ivan Drago, pompa i muscoli in un sofisticato
laboratorio sovietico.
Oggi invece la tecnologia è un’infallibile
depuratore ideologico. Secondo un dogma molto diffuso, viviamo in società
della conoscenza. Molte persone intelligenti sembrano convinte del fatto
che inviare foto con un telefono cellulare implichi un salto evolutivo
cruciale, quando invece piantare mais con una zappa di legno sia un
lavoro degno di uno scimmione subnormale. In realtà, la parte importante
dell’espressione “società della conoscenza” è “società”.
Crediamo disperatamente nelle capacità delle nuove tecnologie della
comunicazione di poter aumentare e fortificare i vincoli fra le persone.
È una cosa molto importante, quando invece la nostra storia recente
è segnata da un progressivo indebolimento delle relazioni sociali.
Le scienze umane si sono mostrate quasi
unanimi nel mettere in relazione la modernizzazione con la distruzione
dei legami comunitari tradizionali. L’industrializzazione, la mercificazione,
la crescita delle città – come anche la democratizzazione e l’Illuminismo
– tendono a far dissolvere il magma simbolico che una volta orientava
le vite individuali e le decisioni collettive. È un processo profondamente
ambiguo: ha generato ansia e disorientamento, ma ci ha anche liberati
delle catene della tradizione: Marx o Durkheim cercarono di affrontare
questo dilemma attraverso scommesse politiche. Gli ideologi del nostro
tempo, invece, pensano che la tecnologia semplicemente dissolva il problema,
creando, da un lato, un circolo virtuoso di libertà e creatività,
e dall’altro un nuovo tipo di densità comunitaria non oppressiva.
Viviamo nell’era del ciberfeticismo.
Non è una cosa frivola che i
tutti i mezzi di comunicazione si affannino a cercare una spiegazione
tecnofila alle sollevazioni popolari in Egitto o in Tunisia nel 2011.
Se uno dà credito al New York Times, il Lenin del Maghreb era
un blogger della classe media esperto nei social network.
Alcuni intellettuali di sinistra sono arrivati a pensare che sia stata
una strategia deliberata per nascondere la relazione di queste rivolte
con la controrivoluzione liberale degli anni ’70. Io credo che sia
stato un modo inconscio di depurare questi movimenti sociali dal loro
inquietante atavismo. La morale ricavata dai ciberfeticisti è che la
potenza rivoluzionaria di Facebook riesce a penetrare anche in un contesto
culturale marcato da un immobilismo allo stadio terminale. In modo davvero
sintomatico, la valutazione che i mezzi di comunicazione, e di sicuro
anche molte persone di sinistra, hanno fatto delle rivolte in Libia
– dove solo il 5% della popolazione ha accesso a Internet – è stata
molto ambigua: “I libici rifiutano la democrazia; a loro piace
avere un capo forte che sia capace di impedire lo scoppio di rivalità
fra tribù. Ma non amano molto il loro capo attuale”, scriveva
Andrew Solomon su El País. Sembra che Twitter ancora non abbia
rivelato ai libici la natura di una genuina emancipazione. In realtà,
accade proprio il contrario. È invece assodato che solo il 21% degli
egiziani ha accesso a Internet. Se i cittadini di questi paesi hanno
fatto un simile salto politico è perché la loro fraternità – il terzo
valore repubblicano – continua a essere nutrita da famiglie allargate,
comunità religiose, circoli di affinità, impegni sindacali e relazioni
culturali dense.
Il feticismo cibernetico è, in fondo,
un sottoprodotto mercificato del vincolo sociale. Più di duecento
anni fa Montesquieu coniò l’espressione “dolce commercio”
per designare il modo in cui gli affari potessero fomentare un tipo
di relazione sociale superficiale, ma amabile e serena. Credeva che
il mercato fosse un’alternativa alle grandi passioni politiche e religiose
che per secoli avevano trasformato l’Europa in un campo di battaglia.
Altri autori hanno radicalizzato questa prospettiva fino ad arrivare
a concepire la socialità non come un fatto primario – una caratteristica
essenziale degli esseri umani -, ma come un fenomeno derivato dalle
relazioni volontarie e considerate mutuamente utili. Nell’era del
capitalismo da casinò, è difficile continuare ad avere questa fiducia
nel potere sociale del mercato. Internet rappresenta un sostituto adatto.
Secondo un’opinione molto diffusa, oggi il cemento delle nostre società
fa presa su uno spazio telematico nel quale si incontrano individui
autonomi senza nessun’altra relazione che i loro interessi comuni.
La verità è che la mercificazione
e i suoi surrogati telematici distruggono i vincoli sociali, non li
creano. Nessuna società può sopravvivere all’ostilità
generalizzata. Per questo la maggior parte delle culture hanno posto
forti limitazioni all’atteggiamento competitivo tipico del commercio,
in cui si cerca di ottenere sistematicamente vantaggi sul nostro concorrente.
Di fatto, il mercato è uno dei pochi spazi della nostra società illuminata
in cui si accetta l’aggressività estrema. Altri due sono Internet
e le autostrade. Secondo alcuni studi, e a dispetto di ciò che ci si
poteva aspettare, le auto decappottabili ricevono meno insulti dal resto
dei guidatori rispetto a qualsiasi altro veicolo. La ragione sembra
essere il contatto visivo diretto con la persona che guida la decappottabile:
nel più profondo delle nostre menti, la socialità e l’empatia si
muovono a un livello paleolitico precedente alle autostrade e a alle
chat. La cosa più simile a una decappottabile che abbiamo nel mondo
delle tecnologie sono i movimenti in favore della libera circolazione
della conoscenza.
Tuttavia, il ciberfeticismo è
molto presente in questi movimenti cooperativi. Molto di frequente,
i partigiani del copyleft (ndt: talvolta tradotto in italiano
come permesso d’autore) centrano la loro attività esclusivamente
nell’eliminazione delle barriere che impediscono la libera circolazione
dell’informazione: monopoli, DRM (Digital Rights Management),
censura, tasse… La cooperazione va intesa come la concorrenza in uno
spazio comunicativo depurato all’estremo, composto da individui uniti
solo da interessi simili, fondamentalmente uno spazio neutrale rispetto
ai contenuti. L’informazione deve fluire, non importa se si tratta
della Critica della ragion pura o di un episodio di Dragon Ball. Non
mi meraviglio se le soluzioni che viene di solito proposte per le esternalità
negative generate dalla liberalizzazione dei contenuti digitali – come
la remunerazione degli autori o il finanziamento di progetti molto costosi
– sono di solito dogmi anarcoliberali maldigeriti. Semplicemente,
si dice che i creatori di copyright vivono di un’industria
obsoleta che il mercato darwiniano si occuperà di depurare se si eliminano
le regolamentazioni.
Per questo, durante l’estenuante
polemica nata attorno alla Legge Sinde, praticamente nessuno ha proposto
qualcosa di talmente semplice come l’eliminazione di questo retaggio
medievale che sono gli enti privati di riscossione delle tasse. La creazione
di un ente pubblico di gestione dei diritti che sostituisca la SGAE
(Sociedad General de Autores y Editores), la VEGAP (Visual
Entidad de Gestión de Artistas Plasticos) o il CEDRO (Centro
Español de Derechos Repográficos) potrebbe assicurare la remunerazione
degli autori evitando gli abusi attuali, per esempio mediante un limite
ragionevole alla quantità che un autore può riscuotere o con un sistema
generoso di eccezioni (mai più asili denunciati per aver cliccato “Al
corro de la patata”!) Un’organizzazione come questa potrebbe
potenziare le libere licenze mediante incentivi fiscali e potrebbe ridistribuire
una parte dei soldi riscossi investendo in progetti culturali. Di fatto
potrebbe dare il via a un forte coinvolgimento delle istituzioni in
difesa della libera conoscenza, creando case editrici, piattaforme di
sviluppo software, studi di registrazione, scuole e archivi digitali
pubblici che creino impiego per i lavoratori del settore e garantiscano,
inoltre, che le produzioni culturali minori, ma di alto valore artistico,
abbiano i mezzi adeguati al loro sviluppo.
Di certo, nessun incantesimo tecnologico,
giuridico o commerciale garantirà il successo di un progetto simile.
Potrebbe convertirsi in un disastroso mostro burocratico corrotto e
arbitrario. Se così non fosse, ciò dipenderebbe da compromessi pragmatici
estremamente fragili. Dipenderebbe dalla supervisione e dall’esigenza
continua da parte dei cittadini. Insomma, dipenderebbe da quella che
comunemente chiamiamo politica.
Fonte: La era del ciberfetichismo
29.12.2011
Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di M. L. SABATINO
CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte
CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALI UFFICIALI TELEGRAM:
Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg
Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie
Salute - https://t.me/CDCPiuSalute
Video - https://t.me/comedonchisciotte_video
CANALE UFFICIALE WHATSAPP:
Principale - ComeDonChisciotte.org