Ringrazio a nome di tutta la Redazione la Dottoressa Margherita Marzario e lo Studio Cataldi per aver acconsentito alla ripubblicazione di questo articolo.
CptHook
Margherita Marzario – Studio Cataldi – 14 apr 2024
Tra i vari esperti lo psichiatra Paolo Crepet mette in guardia da uno dei crescenti pericoli di oggi: “L’utilizzo prolungato dei social media e dei device tecnologici, aumentato negli anni di pandemia, atrofizza il cervello e influisce drasticamente sulla forma mentis dei giovani, il cui apparato cognitivo è continuamente interrotto in un incessante «zapping mentale». Ne consegue un calo delle capacità di attenzione, di lettura, di apprendimento e di memoria: sicuramente un allarme preoccupante da non sottovalutare. I ragazzi non sono più abituati a ragionare con la propria testa, in piena libertà, ma sono condizionati nelle loro scelte dalle opinioni degli influencer”. I genitori dovrebbero avviare (che non significa iscriverli e accompagnarli ai numerosi corsi pomeridiani) e condividere con i figli esperienze di arte, cultura e natura, come previsto anche nella Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura (Bologna, 2011).
Già Giovanni Cavina (1924-2009), “educatore visionario” e ideatore e direttore di una residenza universitaria organizzata come un sorta di “tempio della cultura”, a proposito di scienza e dell’incredibile progresso scientifico, nel 1981 parlava di “amico computer” e affermava: “Se i fruitori delle conoscenze computerizzate saranno più seri, più corretti, più colti, tutto andrà per il meglio; altrimenti, correremo il rischio di essere totalmente manipolati da perdere, con le capacità di immaginazione, di inventiva e di fantasia, la libertà e quindi la felicità” (nella rivista “Panorama per i giovani”). Bambini e ragazzi devono essere educati a usare mezzi tecnologici e device di ogni genere, come mezzi e non come obiettivi della loro vita quotidiana, “senza essere trattati da consumatori ma da soggetti competenti e sensibili” (mutuando la terminologia dell’art. 6 Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura) e preservando tutti i loro diritti.
Alla fine del XIX secolo Lev Tolstoj, scrittore e anche educatore russo, scriveva: “[…] i ragazzi non si lasciano ingannare… Noi cerchiamo di dimostrare che siamo intelligenti, ma essi non se ne interessano affatto, e vogliono sapere se siamo onesti, se siamo sinceri, se siamo buoni, se siamo compassionevoli, se abbiamo una coscienza […]. Un buon insegnante deve avere una buona vita ed una sola è la caratteristica generale e principale di una buona vita: l’aspirazione al perfezionamento nell’amore”. “I bambini hanno diritto […] a essere parte di processi artistici che nutrano la loro intelligenza emotiva e li aiutino a sviluppare in modo armonico sensibilità e competenze” (art. 3 Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura). I genitori non si devono preoccupare solo dell’alimentazione necessaria al corpo dei figli, ma anche del nutrimento della loro interiorità recuperando il vero senso dell’essere genitori: “padre”, colui che sostiene, “madre”, colei che produce. La vita stessa è un processo artistico che richiede intelligenza emotiva: quello di cui dovrebbero occuparsi e preoccuparsi i genitori, ma non sempre è così perché loro stessi non la vivono così o non la rendono così.
L’esistenza dei bambini, lo stare con loro è una delle conferme che il tempo è impalpabile e gli si dà senso e consistenza con relazioni e emozioni, col dare, dire e condire la vita in ogni luogo e uopo. Anche per questo è opportuno che i bambini possano “condividere con la famiglia il piacere di un’esperienza artistica” (art. 9 Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura).
A tale proposito lo psicologo e psicoterapeuta Fabrizio Fantoni precisa: “Come educatori, spesso ci si lamenta che le famiglie sono disunite e poco accoglienti, ma non si lavora abbastanza per formare gruppi in cui i ragazzi si sentano bene e possano costruire la propria identità nelle acque tranquille della squadra. Non tutti sono amici, nel gruppo, e le differenze individuali talvolta pesano nel creare tensioni e malesseri. Occorre che il gruppo si doti di strumenti di manutenzione. Questo è il compito degli educatori: custodire l’idea che si sta percorrendo insieme un cammino comune, dove si sta facendo qualcosa che vale. Tenere vivo l’orgoglio di appartenere a un gruppo speciale. Dare una mano a mediare, delegando loro le responsabilità e dando fiducia ai ragazzi anche quando sbagliano”. “I bambini hanno diritto a vivere esperienze artistiche e culturali accompagnati dai propri insegnanti, quali mediatori necessari per sostenere e valorizzare le loro percezioni” (art. 12 Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura).
“L’arte è unica, insostituibile e universale, perché da sempre, attraverso di essa, l’uomo racconta quello che le parole non sanno e non possono esprimere. Così, rivolgendosi all’arte, egli assegna una forma alle emozioni, ai sentimenti e agli stati d’animo più profondi e inconfessabili che accomunano l’intero genere umano, confidando nella capacità dei suoi simili di comprenderlo fino in fondo” (cit.). L’arte è libertà, linguaggio, comunicazione, emozione, movimento e altro ancora, per cui favorisce lo sviluppo olistico del bambino (art. 27 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia). Il bambino ha “bisogno” di arte e “diritto” all’arte, di cui ci sono espliciti riferimenti negli artt. 13 e 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
A ciò si aggiunge la valenza terapeutica dell’arte: “L’Arteterapia è uno strumento terapeutico che utilizza i materiali artistici per favorire l’esplorazione, l’espressione e l’integrazione dei vissuti corporei, psicologici ed emotivi. Gli elaborati creativi che vengono prodotti non hanno finalità tecniche/estetiche. Sono, bensì, utilizzati come strumento di ascolto, di comunicazione e di espressione del sé, grazie al contatto profondo con alcune sue parti che spesso rimangono inespresse” (cit.). L’arte, prima ancora di essere una forma di terapia, è la principale forma di espressione dei bambini e la scuola dell’infanzia dovrebbe essere la fucina di ogni arte. I bambini sono “artisti” ma gli adulti spesso li reprimono e li rendono stereotipati, conformisti o omologati, come quando nella scuola dell’infanzia si propongono pedissequamente schede fotocopiate, modelli da seguire o altro. Tra i tanti suggerimenti, per esempio, la pedagogista Serena Gaiani propone di incoraggiare bambine e bambini a liberare la propria creatività offrendo esperienze di esplorazione del colore blu, come il pittore Yves Klein. “Disegnare fa bene al cervello” (lo scrittore Luca Novelli).
Bisogna richiamare quello che scrive Alberto Pellai al n. 7 del suo Decalogo per proteggere i bambini (2018): “Diritto ad essere educati alla bellezza. Bellezza delle parole, bellezza delle immagini, bellezza delle relazioni, bellezza della natura. Città grigie e inquinate, canzoni e film pieni di situazioni e parole ostili e volgari; musei, cinema e teatri con costi elevatissimi per genitori che ci vogliono accompagnare i figli: come possono i bambini imparare ad amare il bello quando non è loro reso accessibile e disponibile””.
I bambini: i colori dei loro sorrisi, delle loro guanciotte, delle loro emozioni, della loro presenza, della loro esistenza, i colori della tavolozza della vita.
Margherita Marzario
La Dott.ssa Marzario, docente, laureata con lode in Giurisprudenza e perfezionata in Legislazione minorile presso l’Università degli Studi di Bari, è cultrice di scienze umane e collaboratrice di riviste giuridiche in qualità di giurista minorile. Appassionata di lettura e scrittura, come si evince dal profilo personale su Facebook e dai gruppi FB di cui è amministratrice: “Ricordiamo il Beato Giovanni Paolo II conoscendo i suoi insegnamenti” e “Diritti dei bambini – La nostra Costituzione”. Nata a Salandra, vive a Matera.
Fonte Studio Cataldi: https://www.studiocataldi.it/articoli/46637-i-diritti-dei-bambini-all-arte-e-alla-cultura-nel-postdigitale.asp

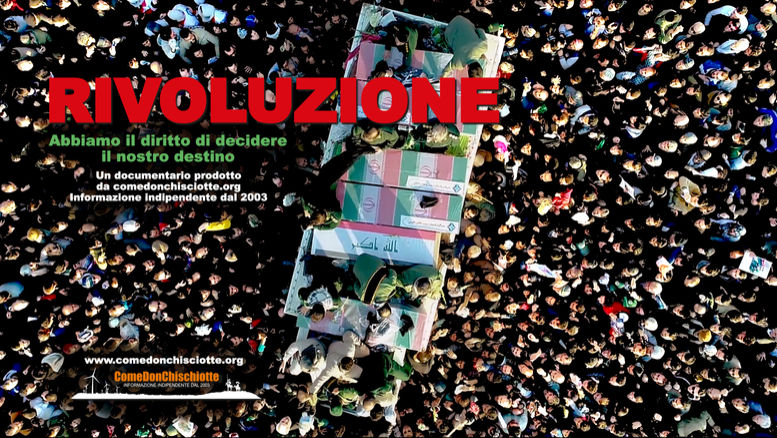
 3165
3165