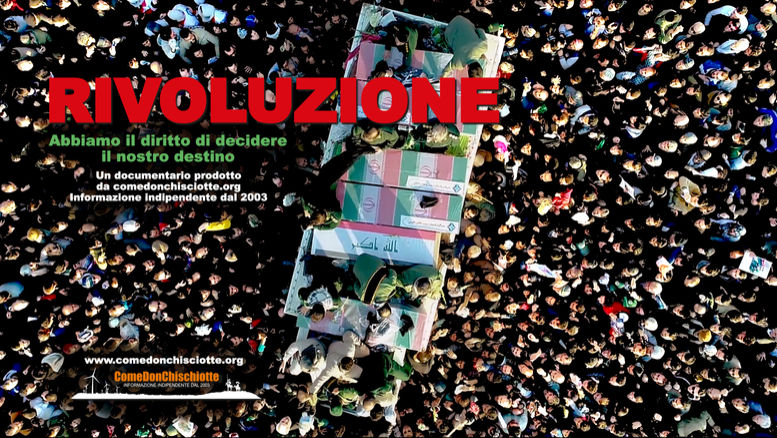vocidallagermania.it
C’era una volta una Germania che, dopo due guerre mondiali, aveva promesso a sé stessa — e al mondo — di non cedere più alla tentazione della forza militare. Oggi, però, il discorso è cambiato. Sottovoce, ma con sempre più decisione, si parla di “kriegstüchtigkeit”, ovvero di “idoneità alla guerra”. E a farlo non sono solo i generali.
Politici, giornalisti, medici: un intero ecosistema culturale e mediatico sembra riscoprire il linguaggio della guerra. Ma è davvero difesa, o siamo di fronte a una nuova forma di propaganda bellica? Quella che non ti ordina, ma ti convince. Quella che non urla, ma insinua.
La guerra comincia dalle parole
Una delle trasformazioni più evidenti è il cambiamento del linguaggio pubblico. I titoli dei quotidiani non lasciano spazio a dubbi: “Deutschland macht mobil”, “Noch vier Jahre bis zum großen Krieg”. Frasi che evocano scenari da anni ’30 e che un tempo sarebbero state bollate come allarmismo o satira.
Oggi, invece, vengono presentate con tono quasi neutro, come parte del dibattito legittimo. Il ministro della Difesa, Boris Pistorius, parla apertamente della necessità di una Bundeswehr “kriegstüchtig”. E nessuno sembra sobbalzare. Ma c’è da chiedersi: quando è diventato normale parlare di guerra così, come se fosse un aggiornamento software da installare?
Da esercito difettoso a forza da 500 miliardi
Per anni, la Bundeswehr è stata lo zimbello d’Europa. Aerei che non volano, fucili che non sparano, carri armati che non partono. Ma oggi la narrativa si è ribaltata. Non solo si parla di ammodernamento, ma di una vera e propria corsa al riarmo, con un budget che sfiora il mezzo trilione di euro.
Il problema non è solo quanto si spende, ma perché e come se ne parla. L’invasione russa dell’Ucraina, le incertezze sulla NATO, il possibile ritorno di Trump: tutto viene usato per costruire un senso di urgenza. Di emergenza. Una paura organizzata che giustifica ogni misura, ogni taglio, ogni rinuncia.
La medicina al servizio del panico: il caso Pennig
Il momento in cui capisci che qualcosa non va è quando anche la medicina entra nel gioco. In un’intervista a Die Welt, Dietmar Pennig, segretario generale di due importanti società di traumatologia, descrive senza battere ciglio uno scenario di guerra urbana, con 1.000 feriti al giorno e ospedali civili pronti a diventare campi di battaglia.
Parla di Berlino, Amburgo, Colonia sotto attacco, di ospedali sotterranei ispirati al modello israeliano, di logistica da tempo di guerra. E tutto questo sulla base di simulazioni NATO. Secondo Pennig, la Germania, con 700.000 soldati stranieri sul suo territorio in caso di guerra, diventerebbe automaticamente un bersaglio militare.
Il giornalista Marcus Klöckner sulle nachdenkseiten.de commenta con lucidità amara: “Ha ancora senso parlare di medicina, o siamo già nella logica del conflitto?” E rincara la dose: “Costruire un ospedale di guerra è come proteggere una casa di carta con altri fogli di carta.”
Non è solo questione di strategia: è il sintomo di un cortocircuito culturale, in cui anche chi dovrebbe curare, finisce per pensare secondo la logica del combattimento.
Habermas avverte: chi controlla il potere armato?
In questo clima, la voce del filosofo Jürgen Habermas risuona come un raro appello alla lucidità. In un intervento sulla Süddeutsche Zeitung, sottolinea che sì, l’Europa ha bisogno di maggiore capacità d’azione, anche militare. Ma questo può avvenire solo in un quadro democratico e condiviso.
Il rischio, secondo lui, è che la Germania, già leader economico, diventi anche potenza militare fuori controllo, senza alcun vincolo europeo reale. E a quel punto, tutto l’equilibrio del continente rischierebbe di saltare.
Non è un’opinione ideologica. È una chiamata alla responsabilità: il potere armato, se non controllato politicamente, è una minaccia anche per chi lo possiede.
Quando i media diventano tamburi di guerra
Se c’è un altro attore che ha abbracciato con entusiasmo questa svolta, sono i grandi media. Titoli sensazionalistici, retorica da fronte interno, scarsa distanza critica. Spesso, più attivisti che cronisti.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung arriva a usare espressioni che, come fa notare Klöckner, richiamano direttamente la propaganda nazista degli anni ’30. Forse inconsapevolmente, ma l’effetto resta lo stesso: creare una narrazione bellicista che anestetizza ogni riflessione.
E quando un giornale si dimentica della storia del proprio Paese, cosa resta del suo ruolo democratico?
Paura + responsabilità = consenso
La forza della propaganda bellica di oggi non sta nell’imposizione, ma nella formula perfetta: paura + responsabilità = consenso.
Ci viene detto: “Non vogliamo la guerra, ma dobbiamo prepararci.” E allora si accetta tutto: i tagli alla sanità, l’aumento delle spese militari, il ritorno della leva, gli ospedali blindati. Chi si oppone? Quasi nessuno. E chi lo fa, viene subito accusato di essere naiv, ingenuo. O peggio, putinversteher – uno che “capisce Putin”.
La vera censura oggi è l’autocensura. La paura di dire: “Fermi tutti. Ma è davvero questa la strada giusta?”
Fermarsi prima che sia troppo tardi
Il caso dell’ospedale sotterraneo a Colonia è emblematico. Un progetto pensato per fronteggiare un attacco diretto. Ma davvero la Germania è sotto minaccia imminente? Davvero c’è bisogno di prepararsi a combattere una guerra dentro le città?
Oppure abbiamo lasciato che la logica del peggio si impadronisse della politica?
Forse è tempo di rimettere le cose in discussione. Di ricordare che costruire ospedali è nobile, ma farlo per una guerra ipotetica — e forse impossibile da vincere — è una sconfitta della ragione.
Come dice Klöckner: “Costruite pace, non ospedali per la guerra”.
Perché la vera forza di una democrazia non è prepararsi alla guerra, ma avere il coraggio di impedirla.
vocidallagermania.it
—
L’ossessione militarista della Germania: il monito profetico di Precht a Lanz
“Quando un Paese civilizzato comincia a parlare di ‘economia di guerra’ con toni quasi nostalgici, è il momento di fare un passo indietro e chiederci dove stiamo sbagliando.“
vocidallagermania.it
Lo studio della ZDF, solitamente teatro di dibattiti vivaci, è immerso in un silenzio carico di tensione. “Non stiamo difendendo la democrazia con questi 900 miliardi per le armi” tuona il filosofo Richard David Precht, “stiamo solo alimentando un circolo vizioso che arricchisce i soliti noti e indebita i nostri figli.”

Il pericoloso déjà-vu del 1914
C’è qualcosa di profondamente inquietante nel modo in cui Precht descriveva le somiglianze tra l’attuale retorica politica e i discorsi che precedettero la Grande Guerra. Prendendo il tablet che Lanz gli aveva passato, sfiorando lo schermo con le dita, fa notare come i giornali del luglio 1914 scrivessero esattamente le stesse cose dei nostri telegiornali oggi. Stesso tono apocalittico, stessi argomenti emotivi, stessa assenza di pensiero critico.
Lanz prova a obiettare citando le dichiarazioni ufficiali sulla presunta “minaccia esistenziale russa”, ma Precht ribatte con numeri che fanno vacillare la narrativa dominante. La Russia ha perso in Ucraina più carri armati di quanti ne abbia mai avuti la Germania unita, il loro PIL è crollato del 35%. Davvero possiamo credere che siano nella posizione di aprire un nuovo fronte? Il vero problema, spiega con pazienza didattica, non è la realtà geopolitica, ma come viene sistematicamente travisata per giustificare scelte che altrimenti apparirebbero folli. “È la sindrome del sonnambulo” commenta, “camminiamo verso il baratro convinti di essere lucidissimi.”
I tre peccati capitali del riarmo
1.Il debito tossico che ipoteca il futuro
Precht denuncia con veemenza la prossima violazione della regola d’oro della Costituzione, quel limite del 0,35% di deficit che la stessa Merkel aveva introdotto nel 2009. Lo stiamo facendo, spiega, per acquistare armamenti che tra dieci anni varranno meno della carta su cui è stampato il contratto. I numeri che cita sono da capogiro: ogni anno fino al 2037 spenderemo 41 miliardi solo per spese militari, accumulando un debito aggiuntivo di 450 miliardi che graverà sui nostri nipoti, mentre già dal 2026 sono previsti tagli da 3,7 miliardi all’istruzione e 2,1 alla sanità. “È come ipotecare la casa per comprare un’auto che perde già olio dal giorno zero” sintetizzava con amara ironia.
2. La farsa della riconversione industriale
Precht racconta l’esempio emblematico della fabbrica di Norimberga che fino al 2022 produceva componenti per auto di lusso esportate in tutto il mondo e oggi assembla proiettili. Mentre i sindacati festeggiano, nessuno dice che quei posti di lavoro sono un inganno collettivo. La differenza è sostanziale: un operaio metalmeccanico nell’industria civile contribuisce all’economia reale creando beni che generano ulteriore ricchezza, mentre lo stesso operaio in fabbrica d’armi produce strumenti di distruzione che, nella migliore delle ipotesi, marciranno in qualche magazzino. “Chiamatela pure riconversione” commenta sarcastico, “ma è come dire che un alcolista si è convertito dall’acquavite alla vodka. Il problema di fondo rimane.”
3. L’illusione della sicurezza assoluta
Precht osserva come nessun generale ammetterà mai che 400 miliardi di armamenti sono perfettamente inutili contro i nuovi missili ipersonici. È un gioco al rialzo senza fine, dove noi spendiamo e la Russia sviluppa contromisure ancora più letali. I dati che citava facevano rabbrividire: con 12.000 testate nucleari russe e i missili Zircon che viaggiano a Mach 9 rendendo obsoleti i sistemi anti-missile, spenderemo un patrimonio per sentirci comunque vulnerabili.

La diplomazia fantasma
Il momento più drammatico arriva quando Precht chiede a Lanz quando fosse stata l’ultima volta che aveva sentito parlare di un negoziato UE-Russia. Il silenzio del conduttore è stato più eloquente di qualsiasi risposta. I numeri della resa diplomatica parlano chiaro: zero incontri ufficiali UE-Russia dal 2022, il budget diplomatico UE tagliato del 40% mentre quello militare raddoppia, solo 12 miliardi spesi in diplomazia nel 2024 contro i 120 miliardi in armi. “Nel 1815” ricordava Precht, “dopo anni di guerre napoleoniche, l’Europa seppe sedersi al tavolo con il nemico sconfitto. Oggi preferiamo parlare solo attraverso i droni.”
L’alternativa che brucia
In chiusura, Precht lancia la provocazione più radicale, invitando a immaginare cosa accadrebbe se quei 900 miliardi fossero investiti in un fondo sovrano per l’innovazione. Gli esempi concreti che portava facevano riflettere: la Norvegia ha creato con il petrolio il più grande fondo pensioni mondiale da 1,4 trilioni, l’Arabia Saudita investe il 50% delle entrate petrolifere in tech e rinnovabili, mentre la Germania butta un terzo del suo bilancio annuale in sistemi d’arma che tra un decennio saranno obsoleti. “Siamo come quell’ubriaco che cerca le chiavi sotto il lampione non perché le ha perse lì, ma perché è l’unico posto dove c’è luce” concludeva con amarezza.
Un monito per il futuro
Mentre l’intervista volge al termine, Precht mostra a Lanz un grafico esplosivo: le ricerche Google su “terza guerra mondiale” in Germania erano aumentate del 740% dal 2022. “La gente sente che qualcosa non quadra” commentava. “Peccato che nelle stanze del potere predomini ancora la logica della paura.” Quel che restava, dopo questa analisi senza sconti, è la netta sensazione che la Germania stia commettendo un errore storico. “Fra vent’anni rideremo di questa follia” profetizzava Precht, “sempre che nel frattempo qualcuno non abbia premuto il bottone per sbaglio.” E in quelle parole c’è tutto il peso di una verità che pochi avevano il coraggio di urlare in prima serata.
(Tutte le dichiarazioni sono tratte dall’intervista a Richard David Precht di Markus Lanz, ZDF 21/03/2025. )
—
Fonte: https://www.vocidallagermania.it/germania-in-allerta-come-la-propaganda-bellica-sta-cambiando-il-volto-di-una-nazione/?doing_wp_cron=1743356254.5313351154327392578125
Fonte: https://www.vocidallagermania.it/lossessione-militarista-della-germania-il-monito-profetico-di-precht-a-lanz/